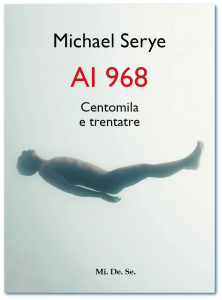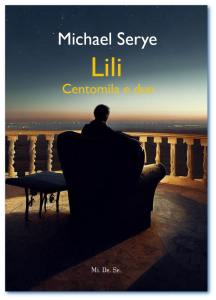JAMES JOYCE Racconto ARABIA Libro GENTE DI DUBLINO Testo ITA
James Joyce
Gente di Dublino
(eng: Dubliners, 1914)
racconto breve
Arabia
(in inglese: Araby)
Testo completo della storia
Tradotto in italiano
Letteratura irlandese
Arabia (titolo originale in inglese: Araby) è un racconto breve scritto da James Joyce
e pubblicato nel 1914. La storia “Arabia” di James Joyce è il terzo racconto del libro (collezione di racconti) intitolato “Gente di Dublino”.
La trama del racconto breve “Arabia” (titolo originale: Araby): la storia narra di un ragazzo segretamente innamorato della sorella del suo vicino e amico. Un giorno ha l’opportunità di parlare con la sua amata: lei gli chiede se vuole andare con lei al bazar chiamato Arabia…
Qui sotto puoi leggere il testo completo del racconto breve di James Joyce “Arabia” (Araby) nella versione tradotta in italiano.
Puoi leggere il racconto breve di James Joyce “Arabia” (Araby) tradotto in altre lingue: Spagnolo, francese, tedesco, cinese, ecc. selezionando la lingua nel menu in alto o laterale.
Indice della raccolta di racconti
del libro di James Joyce Gente di Dublino
(con i links ai racconti da leggere su yeyebook)
Pensione di famiglia
Rivalsa
Polvere
Il giorno dell’edera
Una madre
La grazia
Buona Lettura.
James Joyce Tutti i racconti > qui
James Joyce
Gente di Dublino
racconto breve
Arabia
(Araby)
Testo tradotto in Italiano
Via North Richmond, essendo cieca, era una strada tranquilla salvo all’ora in cui la scuola dei Fratelli Cristiani lasciava liberi i ragazzi. Una casa a due piani disabitata si ergeva all’estremità chiusa, lontana dalle vicine in mezzo a uno spiazzo quadrato. Le altre case della strada, consce delle vite decorose dentro di esse, si fissavano l’un l’altra con brune facce imperturbabili. Il precedente inquilino della nostra, un prete, era morto nel salotto sul retro.
L’aria, stantia per essere stata a lungo rinchiusa, stagnava in tutte le stanze, e il ripostiglio dietro la cucina era cosparso di vecchi giornali inutili. Fra questi trovai qualche libro dalla copertina di cartone, le cui pagine erano arricciate e umide: The Abbot di Walter Scott, The Devout Communicant e The Memoirs of Vidocq. Preferivo quest’ultimo perché i fogli erano gialli. Il giardino selvatico dietro la casa comprendeva un melo centrale e pochi radi cespugli, sotto uno dei quali trovai la pompa da bicicletta arrugginita del defunto inquilino. Era stato un prete molto caritatevole; nel testamento aveva lasciato tutti i suoi soldi a istituzioni e i mobili della casa a sua sorella.
Quando arrivavano le corte giornate invernali, il crepuscolo scendeva prima che avessimo terminato il pranzo. Quando ci incontravamo nella strada le case erano diventate tetre. Lo spazio di cielo in alto era di un colore viola perennemente mutevole e verso di esso i lampioni della strada sollevavano le deboli lanterne. L’aria fredda era pungente e noi giocavamo finché i corpi non ci avvampavano. Le nostre grida echeggiavano nella strada silenziosa.
Le corse dei giochi ci portavano, attraverso gli scuri vicoli fangosi, dietro le case, dove eravamo scherniti dalle rudi tribù dei cottage, fino alle porte di servizio degli scuri giardini stillanti dove si levavano odori dalle fosse delle immondizie, fino alle scure stalle odorose dove un cocchiere lisciava e strigliava il cavallo o, scuotendole, faceva suonare le fibbie dei finimenti. Quando ritornavamo sulla strada, la luce proveniente dalle finestre delle cucine aveva inondato i cortiletti.
Se mio zio veniva visto voltare l’angolo, ci nascondevamo nell’ombra finché non lo vedevamo al sicuro in casa. Oppure se la sorella di Mangan usciva sulla soglia a chiamare dentro per il tè il fratello, dalla nostra ombra la osservavamo scrutare su e giù per la strada.
Aspettavamo a vedere se rimaneva o rientrava e, se rimaneva, lasciavamo l’ombra e ci avvicinavamo rassegnati agli scalini di Mangan. Lei ci aspettava, con la figura delineata dalla luce che usciva dalla porta semiaperta. Il fratello la stuzzicava sempre prima di ubbidire e io me ne stavo vicino alla ringhiera guardandola. Il vestito le oscillava mentre muoveva il corpo e la soffice fune dei capelli dondolava da una parte all’altra.
Ogni mattina mi stendevo sul pavimento del salotto buono sorvegliando la sua porta. La tendina era tirata giù a meno di un pollice dal telaio così che non potevo essere visto. Quando usciva sulla soglia il mio cuore faceva un balzo. Correvo all’ingresso, afferravo i libri e la seguivo. Tenevo sempre d’occhio la sua figura bruna e, quando ci avvicinavamo al punto in cui le nostre strade divergevano, affrettavo il passo e la superavo. Questo accadeva una mattina dopo l’altra.
Non le avevo mai parlato, salvo che per poche parole casuali, eppure il suo nome era come un richiamo a tutto il mio sangue irragionevole. La sua immagine mi accompagnava anche nei luoghi più ostili al romanticismo. Il sabato sera quando la zia andava al mercato dovevo seguirla per portarle una parte dei pacchetti.
Camminavamo per le strade lampeggianti, prendendoci spintoni da ubriachi e donne intente a contrattare, fra le imprecazioni dei manovali, le acute litanie dei fattorini di guardia vicino ai barili di guanciale, i canti nasali degli strimpellatori, che cantavano un venite-con-me su O ‘Donovan Rossa o una ballata sui guai della nostra terra natia.
Questi rumori convergevano per me in un’unica sensazione di vita: immaginavo di portare in salvo il mio calice attraverso una folla di nemici. Il suo nome mi balzava alle labbra a momenti in preghiere e lodi strane che io stesso non capivo. I miei occhi erano spesso pieni di lacrime (che non mi spiegavo) e a volte dal cuore una piena sembrava riversarmisi nel petto.
Pensavo poco al futuro. Non sapevo se le avrei mai parlato o no oppure, se le avessi parlato, come potevo dirle la mia confusa adorazione. Ma il mio corpo era come un’arpa e le parole e i gesti di lei come dita che scorressero sulle corde. Una sera andai nel salotto sul retro dove era morto il prete. Era una sera scura e piovosa e nella casa non c’era un rumore. Attraverso uno dei vetri rotti udii la pioggia venire in urto con la terra e i sottili incessanti aghi d’acqua suonare nelle aiuole inzuppate.
Un lampione lontano o una finestra illuminata scintillavano sotto di me. Ero grato di vedere così poco. Tutti i miei sensi sembravano desiderare velarsi e, senten-do che stavo per sfuggirli, premetti le palme delle mani l’una contro l’altra finché tremarono, mormorando: « O amore! O amore!» molte volte. Alla fine lei mi parlò. Quando mi rivolse le prime parole ero così confuso che non sapevo cosa rispondere.
Mi chiese se andavo all’Arabia. Non ricordo se le risposi sì o no. Sarebbe stato uno splendido bazar; disse che le sarebbe tanto piaciuto andare. «E perché non puoi?» chiesi. Mentre parlava girava e rigirava un braccialetto d’argento intorno al polso. Non poteva andare, disse, perché nel suo convento quella settimana ci sarebbe stato un ritiro.
Il fratello e due altri ragazzi si azzuffavano per i berretti, e io ero solo accanto alla ringhiera. Lei teneva una delle lance, con la testa china verso di me. La luce del lampione di fronte alla nostra porta coglieva la curva bianca del collo, le illuminava i capelli appoggiati lì e, cadendo, illuminava la mano sulla ringhiera. Cadeva su un lato del vestito e coglieva l’orlo bianco di una sottoveste, che si vedeva appena quando non stava dritta. «Tu sì che puoi» disse. «Se vado» dissi «ti porterò qualcosa.» Quali innumerevoli follie devastarono i miei pensieri da sveglio e nel sonno dopo quella sera! Desideravo annientare i giorni noiosi che me ne separavano.
Ero esasperato dal lavoro a scuola. Di notte nella mia camera e di giorno nell’aula l’immagine di lei si frapponeva tra me e la pagina che mi sforzavo di leggere. Le sillabe della parola Arabia, mi venivano gridate nel silenzio in cui la mia anima si crogiolava e gettavano su di me un incantesimo d’oriente. Chiesi il permesso di andare al bazar la sera del sabato. La zia era sorpresa e sperava che non fosse una cosa massonica.
In classe risposi a poche domande. Osservai la faccia dell’insegnante da amabile farsi severa; sperava che non cominciassi a impigrirmi. Non riuscivo a raccogliere i miei pensieri vaganti. Sopportavo a malapena il lavoro serio della vita che, adesso che si frapponeva fra me e il mio desiderio, mi sembrava un gioco infantile, un brutto monotono gioco infantile.
Il sabato mattina ricordai allo zio che la sera desideravo andare al bazar. Stava agitandosi vicino all’attaccapanni dell’ingresso, cercando la spazzola per il cappello, e mi rispose bruscamente: «Sì, ragazzo, lo so». Dato che era nell’ingresso non potevo andare nel salotto buono e stendermi alla finestra. Sentii che la casa era di cattivo umore e mi incamminai lentamente verso scuola.
L’aria era spietatamente fredda e già avevo nel cuore un cattivo presentimento. Quando tornai a casa per pranzo lo zio ancora non era tornato. Ma era presto. Sedetti fissando l’orologio per un po’ e quando il ticchettio cominciò a irritarmi, lasciai la stanza. Salii le scale e raggiunsi il piano superiore.
Le alte, fredde, vuote, cupe stanze mi liberarono e passai di stanza in stanza cantando. Dalla finestra davanti vidi i miei compagni giocare giù nella strada. Le loro grida mi arrivavano indebolite e indistinte e, poggiando la fronte contro il vetro freddo, guardai la casa scura in faccia dove lei viveva. Rimasi lì forse un’ora, non vedendo che la figura bruno-vestita proiettata dalla mia fantasia, toccata discretamente dalla luce del lampione sul collo curvo, sulla mano appoggiata alla ringhiera e sull’orlo sotto il vestito.
Quando scesi giù di nuovo trovai la signora Mercer seduta accanto al fuoco. Era una vecchia garrula, vedova di un prestatore su pegno, che raccoglieva francobolli usati per fini devoti. Dovetti sopportare le chiacchiere del tè. Il pasto venne prolungato oltre un’ora e ancora lo zio non veniva. La signora Mercer si alzò per andare: le dispiaceva non potere aspettare più a lungo, ma erano le otto passate e non voleva stare fuori tardi, dato che l’aria della notte le faceva male. Quando se ne fu andata cominciai a camminare su e giù per la stanza, stringendo i pugni.
La zia disse: «Ho paura che puoi rinunciare al bazar per questa sera di Nostro Signore». Alle nove udii la chiave dello zio nella porta d’ingresso. Lo udii parlare da solo e l’attaccapanni dell’ingresso dondolare quando ebbe ricevuto il peso del cappotto. Sapevo interpretare questi segni. Quando fu a metà del pranzo gli chiesi di darmi i soldi per andare al bazar. Se ne era dimenticato. «La gente ora è a letto e il primo sonno l’ha finito» disse. Non sorrisi. La zia gli disse energicamente: «Non puoi dargli i soldi e lasciarlo andare? Già gli hai fatto fare abbastanza tardi».
Lo zio disse che gli dispiaceva molto essersene dimenticato. Disse che approvava l’antico detto: «Chi troppo studia scemo diventa». Mi chiese dove andavo e, quando glielo dissi una seconda volta, mi chiese se conoscevo L’addio dell’arabo al suo destriero. Quando lasciai la cucina stava per recitare i primi versi alla zia. Tenevo stretta in mano una moneta da due scellini mentre camminavo a gran passi giù per via Buckingham verso la stazione.
La vista delle strade affollate di compratori e splendenti di gas abbagliante mi fece ricordare lo scopo del viaggio. Sedetti in una carrozza di terza classe di un treno deserto. Dopo un insopportabile ritardo il treno si mosse lentamente fuori della stazione. Avanzò piano fra case in rovina e sopra il fiume scintillante. Alla stazione di Westland Row una folla di gente si accalcò agli sportelli della carrozza; ma gli inservienti la spinsero indietro, dicendo che era un treno speciale per il bazar.
Rimasi solo nella carrozza vuota. Dopo pochi minuti il treno si fermò accanto a un improvvisato marciapiede di legno. Uscii sulla strada e vidi dal quadrante illuminato di un orologio che erano le dieci meno dieci. Di fronte a me c’era un grosso edificio che ostentava il magico nome. Non mi riuscì di trovare nessuna entrata da sixpence e, temendo che il bazar fosse chiuso, passai rapidamente attraverso un arganello, tendendo uno scellino a un uomo dall’aria stanca.
Mi trovai in una grande sala cinta a metà altezza da una galleria. Quasi tutti i chioschi erano chiusi e la maggior parte della sala era al buio. Riconobbi un silenzio simile a quello che pervade una chiesa dopo una funzione. Avanzai timidamente fino al centro del bazar. Intorno ai chioschi ancora aperti era riunita un po’ di gente. Davanti a una tenda, sulla quale erano scritte con lampadine colorate le parole Café Chantant, due uomini contavano soldi su un vassoio. Ascoltai le monete cadere. Ricordando con difficoltà perché ero venuto, mi diressi verso uno dei chioschi ed esaminai vasi di porcellana e servizi da tè a fiori.
Alla porta del chiosco una signorina parlava e rideva con due signori giovani. Notai gli accenti inglesi ascoltando distrattamente la conversazione. «Non ho mai detto una cosa simile!» «Ma l’hai detta! » «Ma non l’ho detta! » «Non è vero che l’ha detta?» «Sì. L’ho sentita.» «Oh, che…balla!» Notandomi, la signorina venne a chiedermi se desideravo comprare qualcosa. Il tono della voce non era incoraggiante; sembrava avermi parlato per senso del dovere.
Guardai umilmente i grossi vasi che si ergevano come sentinelle orientali ai due lati della buia entrata al chiosco e mormorai: «No, grazie». La signorina cambiò posto a uno dei vasi e tornò dai due giovani. Ricominciarono a parlare dello stesso argomento.
Una o due volte la signorina mi dette un’occhiata da sopra la spalla. Indugiai davanti al chiosco, sebbene sapessi che rimanere era inutile, per fare sembrare più autentico il mio interesse alla sua merce. Poi mi voltai lentamente e camminai giù per il centro del bazar.
Lasciai i due pennies ricadere in tasca contro il six pence. Udii una voce gridare da un’estremità della galleria che si spegnevano le luci. La parte alta della sala era ora completamente buia.
Fissando lo sguardo in alto nel buio vidi me stesso come una creatura trascinata e schernita dalla vanità e gli occhi mi bruciarono per il tormento e l’ira.
…
..
.
James Joyce
Racconto: Arabia
in inglese: Araby
dal libro: Gente di Dublino
In inglese: Dubliners (1914)
Letteratura irlandese
James Joyce Arabia (Araby) Testo originale in inglese > qui
James Joyce Tutti i racconti > qui
James Joyce
James Joyce (Dublino, 2 febbraio 1882 – Zurigo, 13 gennaio 1941), è stato uno scrittore, poeta e drammaturgo irlandese. Lo scrittore irlandese James Joyce è ritenuto uno dei migliori scrittori del XX secolo e della letteratura di ogni tempo, anche se la sua produzione letteraria non sia molto vasta.