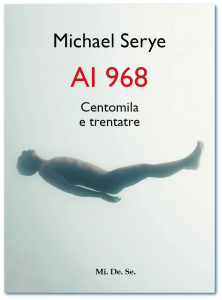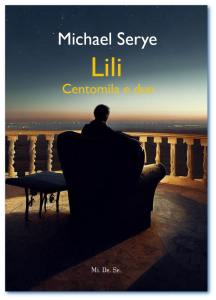E. A. POE Racconto MANOSCRITTO TROVATO IN UNA BOTTIGLIA ITA
Edgar Allan Poe
Manoscritto
trovato in una bottiglia
(1833)
(eng: MS. Found in a Bottle)
Letteratura statunitense
Racconto dell’orrore
Testo completo tradotto in italiano
Edgar Allan Poe Tutti i racconti > qui
Breve introduzione
Manoscritto trovato in una bottiglia (originale in lingua inglese: MS. Found in a Bottle) è un racconto breve dell’orrore marinaro scritto dal grande scrittore americano Edgar Allan Poe.
Manoscritto trovato in una bottiglia di Edgar Allan Poe fu pubblicato per la prima volta il 19 ottobre 1833 sul Baltimore Saturday Visiter, e vinse il premio di 50 dollari indetto dallo stesso periodico.
Edgar Allan Poe (Boston, 1809 – Baltimora, 1849) è considerato uno dei più grandi e influenti scrittori statunitensi della storia. Edgar Allan Poe è stato un pioniere del racconto poliziesco, dei racconti di orrore e del giallo psicologico.
Qui sotto trovi il testo completo del racconto breve “Manoscritto trovato in una bottiglia” di E. Allan Poe tradotto in italiano.
Più sotto trovi la video lettura – audiolibro del racconto breve dell’orrore “Manoscritto trovato in una bottiglia” di E. A. Poe con lettura in italiano.
Buona lettura e/o buon ascolto e Attenti ai naufragi!
Edgar Allan Poe Leggi o compra tutti i suoi Libri o Ebook > qui
Edgar Allan Poe
Manoscritto
trovato in una bottiglia
(1833)
Racconto dell’orrore
Traduzione del testo in Italiano
Qui n’a plus qu’un moment à vivre
N’a plus rien à dissimuler.
Quinault, Atys
Non ho molto da dire del mio paese e della mia famiglia.
I cattivi trattamenti, e il passar degli anni, mi hanno cacciato da quello e reso estraneo all’altra. Il mio patrimonio ereditario mi permise di procacciarmi un’educazione non comune, e il mio spirito contemplativo di classificare con metodo il materiale che lo studio precoce aveva diligentemente raccolto.
Più di ogni altra cosa le opere dei filosofi tedeschi mi procurarono grandi delizie; non per una sconsigliata ammirazione della loro follia eloquente, ma per la facilità che mi davano le mie abitudini di pensiero rigoroso, di scoprire le loro falsità.
Sono stato spesso rimproverato dell’aridità del mio ingegno; la mancanza di fantasia mi è stata imputata come un delitto, e il pirronismo delle mie opinioni mi ha sempre dato notorietà. Temo invero che una forte inclinazione per la filosofia fisica abbia comunicato alla mia mente uno degli errori più comuni del secolo, voglio dire quello di riportare ai principi di questa scienza anche le circostanze meno suscettibili di tale rapporto. In fondo nessuno poteva essere meno soggetto di me a lasciarsi trascinare oltre i severi recinti del vero dagli “ignes fatui” della superstizione. Ho creduto bene premettere tutto questo, perché il racconto incredibile che sto per fare non venga attribuito all’esaltazione di una cruda fantasia piuttosto che all’esperienza positiva di una mente per la quale gli abbagli dell’immaginazione non sono mai esistiti.
Dopo di aver passati molti anni in lontani viaggi, m’imbarcai, nel 18…, a Batavia, capitale della ricca e
popolosa isola di Giava, per un viaggio nell’arcipelago della Sonda. Avevo posto a bordo in qualità di passeggero, e non ero mosso da altro che da una irrequietezza nervosa che mi perseguitava come uno spirito maligno.
Il nostro bastimento era una bella nave di circa 400 tonnellate, rinforzato in rame, costruito a Bombay in legno di teck del Malabar. Portava un carico di cotone e d’olio delle isole Laccadive. Avevamo a bordo anche copra, vino di palma, spezie varie, noci di cocco e qualche cassa d’oppio. Lo stivaggio era stato fatto male e di conseguenza la nave inclinava.
Partimmo con un soffio di vento e per vari giorni rasentammo la costa orientale di Giava, senza che la monotonia della nostra rotta venisse turbata da nessun incidente, all’infuori dell’incontro con alcuni dei piccoli battelli dell’arcipelago verso il quale eravamo diretti.
Una sera mentre stavo appoggiato alle bastinghe del casseretto osservai una nuvola singolarissima, isolata, dalla parte di nord-ovest. Era degna di nota tanto per il colore, quanto perché era la prima che avessimo visto dalla nostra partenza da Batavia. La osservai attentamente sino al tramonto quando, tutt’a un tratto, si allargò dall’est all’ovest circondando l’orizzonte di una stretta cintura di vapore che sembrava una lunga linea di costa bassa.
Poco dopo la mia attenzione fu attratta dal colore rosso-cupo della luna e dal carattere singolare del mare. Questo andava subendo un rapido cambiamento, l’acqua appariva più trasparente del consueto. Benché discernessi chiaramente il fondo, pure, gettato lo scandaglio, trovai quindici tese d’acqua. L’aria era diventata insopportabilmente calda ed era impregnata di esalazioni acute simili a quelle che manda il ferro riscaldato.
Col calar della notte il vento cessò del tutto. La calma divenne totale, assoluta. La fiamma di una candela ardeva a poppa senza la minima vibrazione, si poteva tenere un lungo capello fra il pollice e l’indice senza avvertire la più piccola oscillazione. Ciò nonostante, il capitano, asserendo di non scorgere alcun segno di pericolo e che si andava in deriva verso terra, comandò di ammainare le vele e di gettar l’ancora.
Non furono messe vedette e gli uomini dell’equipaggio, malesi in massima parte, si stesero senz’altro sopra coperta. Scesi sotto coperta, non senza il pieno presentimento di una disgrazia. In realtà tutti quei segni mi davano ragione di temere un simun. Feci cenno al capitano delle mie paure, ma egli non badò minimamente a quello che dicevo e se ne andò senza degnarsi di rispondermi.
Tuttavia la mia preoccupazione m’impedì di dormire e verso la mezzanotte salii sul ponte. Come mettevo il piede sull’ultimo gradino, fui colpito da un rombo cupo, profondo, simile a quello prodotto dalla rapida rivoluzione di una macina di mulino, e prima che ne potessi accertare la ragione, sentii che la nave tremava sul suo centro.
Il momento dopo un turbine di schiuma ci piegò sul fianco e investendoci davanti e di dietro spazzò interamente il ponte da poppa a prua. Alla furia estrema del vento si dovette, in gran parte, la salvezza della nave. Per quanto sommersa dall’acqua, un momento dopo, schiantatisi gli alberi, essa si sollevò
lentamente dal mare, e, vacillando alcuni minuti sotto l’enorme pressione della tempesta, finì per raddrizzarsi.
Per qual miracolo sfuggissi alla morte è impossibile a dirsi. Stordito dal colpo dell’onda, mi trovai, quando
rinvenni, preso fra le ruote di poppa e il timone. Con grande fatica mi rialzai, e girando lo sguardo vertiginosamente intorno, fui anzitutto colpito dall’idea che ci trovassimo tra i frangenti di qualche scogliera, tanto appariva, oltre ogni immaginazione, spaventevole lo schiumante turbine dell’oceano nel quale eravamo ingolfati. Dopo un poco udii la voce di un vecchio svedese che si era imbarcato proprio quando stavamo per uscire dal porto. Lo chiamai con tutte le mie forze e subito egli mi raggiunse, barcolloni. Ben presto ci rendemmo conto che eravamo i soli superstiti del disastro.
Tutti in coperta, eccettuati noi, erano stati spazzati via dal ponte; il capitano e gli ufficiali dovevano esser periti nel sonno, poiché le cabine erano state inondate dall’acqua.
Non potevamo sperare, senza aiuto, di fare gran che per la sicurezza della nave; d’altra parte la persuasione che avevamo di colare a picco da un momento all’altro paralizzava ogni nostra velleità. La corda dell’ancora si era spezzata come uno spago da involti al primo soffio dell’uragano; altrimenti saremmo stati travolti nell’istante.
Fuggivamo davanti al mare con una velocità spaventevole, l’acqua apriva falle visibili al disopra di
noi. L’armatura della poppa era danneggiata gravemente; sotto quasi tutti i rapporti avevamo sofferto avarie; ma con nostra estrema gioia trovammo che le pompe funzionavano ancora, e che il carico non s’era spostato di troppo. La maggior furia della tempesta era ormai passata e poco restava da temere dalla violenza del vento; ma anticipavamo con terrore il caso che cessasse del tutto, convinti che, nella nostra condizione, non avremmo potuto resistere alla marea formidabile che ne sarebbe risultata. Ma questo giusto timore non sembrava davvero doversi verificare tanto presto.
Per cinque notti e cinque giorni – durante i quali ci nutrimmo esclusivamente di alcuni pezzi di zucchero di palma, presi con gran fatica a prua – la nave filò con una velocità incalcolabile, davanti a riprese di vento che si succedevano rapidamente e che, pur non essendo uguali alla prima violenza del simun, erano sempre più forti di qualunque tempesta che avessi vista sino allora.
Nei quattro giorni la nostra rotta fu, salvo leggerissime variazioni, al sudsud-est; tanto che abbiamo dovuto passare vicino alle coste della Nuova Olanda. Il quinto giorno il freddo divenne estremo quantunque il vento avesse girato d’un punto al nord. Il sole si levò con un malinconico riflesso giallo e si alzò appena di qualche grado sull’orizzonte, senza emanare una luce decisa.
Non vi erano nuvole in vista, eppure il vento rinfrescava soffiando con furia irregolare. Verso mezzogiorno, per quanto potemmo giudicare, la nostra attenzione fu di nuovo attratta dall’aspetto del sole. Non dava luce, quel che si chiama luce, ma un bagliore cupo e triste senza alcun riflesso, come se tutti i suoi raggi fossero polarizzati. Un momento prima d’immergersi nel mare che andava ingrossando, il suo
fuoco centrale si estinse di un tratto come spento da una forza inesplicabile, e quando scomparve nell’oceano incommensurabile non era più che un esile anellino d’argento.
Invano attendemmo l’alba del sesto giorno – questo giorno per me non è ancora giunto – per lo svedese non arrivò mai. Da allora in poi fummo avvolti di fittissime tenebre, tali che non avremmo potuto scorgere un oggetto a venti passi dalla nave. La notte eterna seguitò ad avvilupparci, non rischiarata nemmeno dalla brillante fosforescenza del mare, a cui eravamo abituati sotto i tropici. Osservammo pure che, sebbene la tempesta continuasse furiosa senza un momento di tregua, non si scopriva più alcun segno della schiuma che ci aveva accompagnati sino allora.
Tutto intorno era orrore, fitta oscurità, un nero deserto di liquido ebano. Un terrore superstizioso s’infiltrava a mano a mano nello spirito del vecchio svedese, e l’anima mia era invasa da un muto stupore. Avevamo abbandonato ogni cura della nave come cosa più che inutile e, aggrappandoci come meglio potevamo al moncone dell’albero di mezzana, volgevamo amaramente gli sguardi sull’immensità dell’oceano.
Non avevamo alcun mezzo di calcolare il tempo, né potevamo far congetture sulla nostra situazione. Eravamo tuttavia ben certi d’essere arrivati più al sud di qualunque altro navigatore, e ci stupiva molto di
non incontrare le solite barriere di ghiaccio. Frattanto ogni minuto minacciava d’essere l’ultimo. L’altezza delle onde superava ogni immaginazione, era un miracolo continuo di non essere inghiottiti. Il mio compagno parlò della leggerezza del carico e mi rammentò le buone qualità della nave; ma io non potevo fare a meno di sentirmi assolutamente privo di speranza, e mi preparavo così tristemente a quella morte che nulla mi pareva potesse protrarre oltre un’ora, poiché a ogni nodo che la nave avanzava, l’altezza di quel prodigioso mare nero diventava sempre più spaventevole.
A volte, sollevati sino alle altezze nelle quali vola l’albatro, ci mancava il respiro, e a volte eravamo presi da vertigine per la velocità della nostra discesa in un inferno liquido, dove l’aria diventava stagnante e nessun suono disturbava i sonni del kraken.
Fu dal fondo di uno di questi abissi, che un urlo improvviso del mio compagno ruppe lugubremente la notte:
«Guardate! guardate!» mi gridò nelle orecchie. «Onnipossente Iddio! guardate! guardate!». Scorsi allora una luce rossa, di un cupo e triste bagliore che si muoveva lungo le pareti dell’immenso abisso nel quale eravamo, inondandoci di un vacillante riflesso.
Alzando gli occhi vidi uno spettacolo che mi agghiacciò il sangue. Proprio sopra di noi, a una terribile altezza, sull’ultimo orlo del precipizio, era una nave gigantesca di forse quattromila tonnellate. Benché inerpicata sulla cresta di un’onda cento volte più grande di lei, pure essa appariva di dimensioni maggiori di qualsiasi vascello da guerra, o della “Compagnia delle Indie Orientali”. Il suo enorme scafo era di un nero cupo, non rotto dai soliti intagli delle navi.
Una unica fila di cannoni sporgeva dai contrasportelli aperti riflettendo sulle loro superfici lucide le
fiaccole d’innumerevoli fanali di battaglia che dondolavano sull’attrezzatura. Ma quello che soprattutto ci
riempì di orrore e di stupore fu che andava con tutte le vele spiegate, incontro a quel mare soprannaturale, a quel furioso uragano. Al primo vederla non ci fu possibile scorgerne che la prua, poiché si alzava lentamente dallo scuro e orribile baratro che s’era lasciato dietro.
Per un istante, intenso di terrore, si fermò sulla cima vertiginosa, quasi in contemplazione della propria altitudine, poi tremò, si scosse, e scivolò sulla china. A quel momento non so quale improvvisa padronanza di sé prese il mio spirito. Barcollando verso la poppa quanto più potei, attesi senza paura la catastrofe che ci doveva sopraffare. Il nostro bastimento, alla fine, smetteva di lottare col mare e affondava da prua.
L’urto della massa precipitante lo colpì, di conseguenza, nella parte dello scafo che era quasi sommersa con l’inevitabile risultato di lanciarmi nell’attrezzatura della nave straniera. Nel mentre cadevo, questa si sollevò, poi virò di bordo; e io attribuisco alla confusione che seguì, se non attrassi l’attenzione dell’equipaggio. Non visto potei giungere senza molta fatica sino al boccaporto principale che era
socchiuso e trovare così una occasione propizia per nascondermi nella cala. Perché facessi così non saprei ben dire. Forse vi fui spinto da un vago sentimento di terrore che si era impossessato di me all’aspetto degli uomini di bordo.
Non ero disposto a fidarmi di persone che, alla occhiata sommaria che avevo gettato su di loro, mi avevano presentato tanti caratteri d’una indefinibile novità e motivi di dubbio e di timore. Procurai perciò di trovarmi un nascondiglio nella cala, ciò che ottenni spostando una piccola parte del tavolato mobile, così da trovare un ricovero conveniente fra le enormi travi della nave.
Avevo appena finito il mio lavoro che un rumore di passi nella cala mi costrinse ad approfittarne. Un uomo rasentò il mio nascondiglio con passo incerto e vacillante. Non potei vederlo in viso, ma ebbi modo di osservare il suo aspetto generale, che presentava tutti i caratteri della vecchiaia e della infermità. I ginocchi gli barcollavano sotto il peso degli anni, e tutto il suo corpo tremava. Borbottava fra sé, a voce bassa e tronca, parole di una lingua che non comprendevo, e cercava a tastoni in un angolo dove erano ammucchiati strumenti di aspetto singolare e logore carte di navigazione.
I suoi modi erano uno strano miscuglio della malagrazia di una seconda infanzia e della dignità solenne di un Dio. Poco dopo risalì sul ponte e non lo rividi più.
Un sentimento che non so come nominare si è impossessato dell’anima mia; una sensazione che non ammette analisi, per la quale sono inadeguate le lezioni del passato e della quale temo che nemmeno l’avvenire mi darà la chiave. Per una mente costituita come la mia, quest’ultima considerazione è un male. Non potrò mai – so che non potrò mai – essere appagato relativamente alla natura dei miei concetti. Però non c’è da meravigliarsi se questi concetti sono indefinibili, dal momento che provengono da sorgenti così interamente nuove.
Un nuovo sentimento, una nuova entità si è aggiunta all’anima mia.
È passato molto tempo da quando posi per la prima volta piede sul ponte di questa terribile nave; i raggi del mio destino, mi sembra, vanno concentrandosi in foco. Che gente incomprensibile! Sprofondati in meditazioni delle quali non arrivo a comprendere la natura, mi passano accanto senza accorgersi di me.
Nascondermi è veramente da matti; questa gente non vuol vedere. Un momento fa, passavo sotto gli occhi del secondo; poco tempo prima mi ero avventurato sino nella cabina dello stesso comandante e fu là che presi il necessario per scrivere di cui mi son servito e mi servo. Di tempo in tempo continuerò questo giornale. È vero che può non offrirsi alcuna occasione per trasmetterlo al mondo; ma non mancherò di tentare. All’ultimo momento chiuderò il manoscritto in una bottiglia e lo getterò in mare.
È avvenuto un incidente che mi ha dato molto da riflettere. Possono simili cose essere opera del caso non disciplinato? Mi ero avventurato sul ponte e, senza attrarre l’attenzione di alcuno, mi ero buttato su un mucchio di corde e di vecchie vele nel fondo del canotto. Nel mentre riflettevo sulla singolarità del mio destino, inavvertitamente imbrattavo con una spazzola da catrame la punta di una vela che stava ripiegata con cura sopra un barile accanto a me. Adesso la vela è spiegata sulla nave, e i tocchi involontari della spazzola formano la parola “SCOPERTA”.
Ultimamente ho fatto le mie osservazioni sulla struttura del vascello. Quantunque ben armato, non è, mi sembra, una nave da guerra. La sua attrezzatura, costruzione ed equipaggiamento generale non ammettono tale ipotesi. Quello che non è, lo vedo facilmente, ma quello che è temo che sia impossibile dirlo. Non so come sia, ma osservando il bizzarro modello e la forma strana delle sue chiglie, le sue proporzioni gigantesche, la sua prodigiosa velatura, la severa semplicità della prua e lo stile antiquato della poppa, talora mi passa attraverso la mente una sensazione di cose che mi sono familiari e sempre a
queste ombre indistinte di ricordi si mescola l’inesplicabile memoria di vecchie cronache straniere e di età antichissime.
Ho osservato l’armatura della nave. È fatta di materiale che mi è sconosciuto. Vi è una caratteristica del legno, che mi sembra doverlo rendere improprio all’uso a cui è destinato. Voglio dire la sua estrema porosità, considerata indipendentemente dall’essere così tarlata, ciò che è conseguenza della navigazione in questi mari e della putrefazione cagionata dalla sua età. La mia osservazione parrà forse un po’ troppo sottile, ma mi sembra che questo legno avrebbe ogni caratteristica della quercia di Spagna, se questa si potesse dilatare con mezzi artificiali.
Rileggendo questa ultima frase mi ritorna alla memoria un curioso apoftegma di un vecchio lupo di mare olandese: “Questo è altrettanto vero” diceva, quando veniva manifestato qualche dubbio sulla veracità delle sue parole “come è vero che vi è un mare, dove la nave stessa ingrassa come il corpo vivente del marinaio”.
Circa un’ora fa ho avuto l’ardire di mescolarmi a un gruppo di uomini dell’equipaggio. Non hanno fatto nessuna attenzione a me e, benché stessi proprio nel mezzo di loro tutti, pareva che non avessero coscienza alcuna della mia presenza. Come quello che avevo veduto prima nella stiva, portavano tutti i segni d’una grande vecchiaia. I loro ginocchi vacillavano di debolezza, avevano le spalle curve sotto il peso degli anni, la loro pelle raggrinzita fremeva al vento, la loro voce era bassa, tremula, tronca; dai loro occhi stillavano lagrime di vecchiaia; i loro capelli grigi erano orribilmente sbattuti dalla tempesta. Intorno a loro per ogni parte del ponte, giacevano sparsi strumenti matematici di costruzione curiosissima e disusata.
Ho parlato, poco fa, di una vela che avevano spiegato. Da allora, la nave, messa tutta nel vento, ha continuato la sua terribile corsa diritto al sud carica di tutte le vele disponibili, dalle punte degli alberi fino ai più bassi buttafuori, immergendo le cime nel più spaventevole inferno liquido che sia concepibile a mente umana. Ho lasciato or ora il ponte, dove non mi è possibile reggermi, mentre l’equipaggio non ha l’aria di risentirne molto scomodo.
Mi sembra il miracolo dei miracoli che la nostra enorme massa non venga inghiottita subito e per
sempre. Siamo certamente condannati a costeggiare per sempre l’orlo dell’eternità senza far mai il tuffo definitivo nell’abisso. Scivoliamo con la velocità di freccia del gabbiano su ondate mille volte più prodigiose della più prodigiosa che abbia mai veduta; altre gigantesche elevano le loro creste sopra di noi come demoni dell’abisso, ma come demoni che possano solo minacciare guardandosi bene dal distruggere.
Sono condotto ad attribuire questi continui salvamenti alla sola causa naturale capace di spiegarli. Bisogna supporre che la nave sia portata da una forte corrente sottomarina, o da un risucchio impetuoso.
Ho veduto il capitano faccia a faccia e nella sua stessa cabina; ma, come prevedevo, egli non ha dato segno d’essersi accorto di me. Per quanto nel suo aspetto non vi sia nulla che riveli all’osservatore casuale alcun che di superiore o d’inferiore ad un altro, pure un sentimento d’irreprimibile riverenza si mescolò alla sensazione di stupore ispiratami dalla sua vista. Egli è press’a poco della mia statura, misura cioè circa cinque piedi e otto pollici. Di costituzione è ben fatto e ben proporzionato, né particolarmente robusto, né notevole per altro verso; è la singolarità dell’espressione che regna sul suo viso, e l’intensa, stupenda, impressionante evidenza di una vecchiaia così assoluta, così estrema, che suscita nel mio spirito un senso, un sentimento ineffabile. La sua fronte, sebbene non molto solcata da rughe, sembra portare il suggello di miriadi di anni. I suoi capelli grigi sono documenti del passato e i suoi occhi anche più grigi sono sibille dell’avvenire.
L’impiantito della sua cabina era ingombro di curiosi in-folio a fermagli di ferro, di logori strumenti scientifici e di antiche carte geografiche di specie da lungo tempo dimenticata. Teneva il capo reclino nelle mani, e divorava con occhio ardente e irrequieto un foglio che io presi per un ordine, e che, ad ogni modo, portava la firma di un monarca. Mormorava tra sé – come il primo marinaio che avevo visto nella stiva – sillabe cupe e tristi di una lingua straniera; e sebbene mi trovassi al suo gomito, la sua voce sembrava giungermi da un miglio di distanza.
La nave, e tutto ciò che contiene, è imbevuta dello spirito di Eld. I marinai dell’equipaggio scivolano qua e là come le ombre dei secoli sepolti; nei loro occhi è un significato ansioso e inquieto; e quando le loro dita passano sulla mia strada nello strano riflesso dei fanali, provo qualche cosa che finora non ho mai provato; quantunque io abbia trascorso l’esistenza fra le antichità e mi sia immerso nell’ombra delle colonne dirute di Balbec, di Tadmor e di Persepoli, al punto che anche la mia anima è diventata una rovina.
Quando giro intorno lo sguardo, mi vergogno delle mie prime paure. Se tremavo all’uragano che ci ha perseguitati sinora, non dovrei ora allibire d’orrore davanti a un lottare di venti e d’oceano, per dare la minima idea del quale le parole turbine e simun sono banali e inefficaci?
Attorno alla nave è la tenebra della notte eterna e un caos d’acqua senza spuma; ma alla distanza di circa una lega, da ciascun lato si possono distinguere, confusamente e a intervalli, prodigiosi bastioni di ghiaccio torreggianti nel cielo desolato e sembrano le mura dell’universo.
Come l’avevo immaginato, la nave si trova in una corrente, se si può dar questo nome a una marea che, muggendo e urlando spaventosamente lungo il candido ghiaccio, scroscia verso il sud con la velocità del precipitoso cadere a picco di una cateratta. Suppongo che sia assolutamente impossibile concepire
l’orrore delle mie sensazioni; tuttavia la curiosità di penetrare i misteri di queste regioni spaventose vince anche la mia disperazione e mi riconcilierà col più orribile aspetto della morte. È evidente che si va precipitosamente verso qualche scoperta di grande interesse, qualche segreto da non potersi mai trasmettere, la cui conoscenza porta alla morte.
Forse questa corrente ci trascina allo stesso Polo sud. Bisogna confessare che questa supposizione, per strana che possa sembrare, ha ogni probabilità dalla sua. Gli uomini dell’equipaggio percorrono il ponte con passo inquieto e trepido; ma sulle loro fisionomie si legge piuttosto l’ardore della speranza che l’apatia della disperazione. Abbiamo sempre il vento in poppa, e poiché corriamo con tutte le vele spiegate, a volte la nave emerge quasi interamente dal mare! Oh! orrore degli orrori! Il ghiaccio si apre improvvisamente a destra e a sinistra e noi giriamo vertiginosamente su immensi circoli concentrici torno torno all’orlo di un gigantesco anfiteatro, il sommo delle cui pareti si perde nelle tenebre e nella distanza.
Ma poco più tempo mi è lasciato per riflettere al mio destino!
I cerchi si restringono, rapidamente, c’immergiamo vertiginosamente nella stretta del vortice, e in mezzo all’urlio, allo scroscio, al tuonare dell’oceano e della tempesta, la nave trema, oh! Dio! e… affonda!…
…
..
.
Nota. Il Manoscritto trovato in una bottiglia fu pubblicato per la prima volta nel 1831, e fu solo molti anni dopo che venni a conoscenza delle carte di Mercator, nelle quali l’oceano è rappresentato come precipitantesi da quattro bocche nel Golfo polare (del nord), per essere assorbito nelle viscere della terra; il Polo stesso essendovi rappresentato da una roccia nera, torreggiante a una prodigiosa altezza.
E. A. P.
…
..
.
Edgar Allan Poe
Manoscritto trovato in una bottiglia
Originale inglese: MS. Found in a Bottle (1833)
Letteratura statunitense
Racconto breve – orrore marinaro
Testo completo tradotto in italiano
E. A. Poe MS. Found in a Bottle Versione originale in inglese > qui
Edgar Allan Poe Leggi o compra tutti i suoi Libri o Ebook > qui
Edgar Allan Poe Tutti i racconti > qui
Video Audiolibro
Manoscritto Trovato in una Bottiglia di E. A. Poe
Voce Narrante di E. Camponeschi