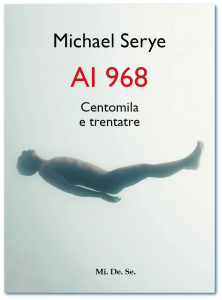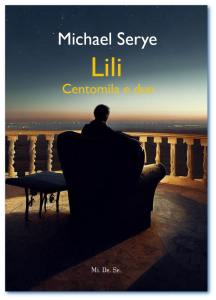ANTON ČECHOV Racconto IL MONACO NERO Testo tradotto Italiano
Anton Čechov
Il monaco nero
(Ru: Čërnyj monah)
(1894)
Racconto russo
letteratura russa – scrittori russi
testo tradotto in italiano
Anton Čechov Tutti i racconti > qui
Il monaco nero (in russo: Čërnyj monah) è un racconto di Anton Čechov, pubblicato per la prima volta nel 1894.
Il racconto ” Il monaco nero “ è considerato un’opera autobiografica dello scrittore russo Anton Čechov.
L’eccitazione mentale che tormenta e contemporaneamente rende felice il protagonista del racconto ” Il monaco nero “ è simile all’eccitazione mentale dello scrittore Anton Čechov, come pure la tubercolosi che uccide il protagonista è la stessa patologia di cui soffriva Anton Čechov e che lo ha portato alla morte.
A seguire il testo completo del racconto di Anton Čechov: “Il monaco nero” tradotto in Italiano.
Nel menù in alto o a lato trovi il racconto di Anton Čechov: “Il monaco nero” tradotto in altre lingue: francese, tedesco, spagnolo, cinese, ecc.
Buona lettura.
Anton Čechov
Il monaco nero
(Ru: Čërnyj monah)
I
Andrej Vasil’ič Kovrin, professore universitario, era affaticato e aveva i nervi fuori posto. Non si curava, ma una volta, di sfuggita, intorno a una bottiglia di vino, ne parlò con un amico medico, e quello gli consigliò di passare la primavera e l’estate in campagna. Arrivò proprio a proposito una lunga lettera da Tanja Pesockaja, che lo pregava di andare in visita a Borisovka. E decise che un viaggetto gli ci voleva proprio.
Prima – in aprile – andò a casa sua, nella natia Kovrinka, e qui passò da solo tre settimane; poi, quando le strade furono percorribili, si diresse in carrozza dal suo ex tutore ed educatore Pesockij, frutticoltore famoso in Russia. Da Kovrinka a Borisovka, dove abitavano i Pesockij, non c’erano più di settanta verste, e viaggiare per le lisce strade primaverili in una comoda carrozza molleggiata era un vero piacere.
La casa di Pesockij era enorme, con colonne, con leoni dall’intonaco scrostato e un cameriere in frac all’ingresso. L’antico parco, tetro e austero, suddiviso all’inglese, si estendeva per quasi una versta dalla casa fino al fiume e qui finiva in una ripida, scoscesa riva argillosa sulla quale crescevano pini con le radici nude che sembravano zampe pelose; giù l’acqua riluceva solitaria, svolazzavano i chiurli con un pigolio lamentoso, e qui veniva sempre voglia di sedersi a comporre una ballata. Invece vicino alla casa, in cortile e nel frutteto, che insieme ai vivai occupava una trentina di ettari, era allegro e veniva voglia di vivere anche quando il tempo era brutto. Rose, gigli, camelie così stupefacenti, tulipani così variopinti, dal bianco lucido al nero fuliggine, in generale una tale ricchezza di fiori come c’era da Pesockij a Kovrin non era mai successo di vederla da nessuna parte.
La primavera era ancora solo all’inizio e le fioriere più lussureggianti erano ancora nascoste nelle serre, ma già quello che era fiorito lungo i vialetti e qua e là nelle aiuole era sufficiente per sentirsi, passeggiando per il giardino, nel regno delle tinte tenui, specie alle prime ore, quando su ogni petalo brillava la rugiada.
Quella che era la parte decorativa del giardino e che Pesockij stesso denigrava dicendo che erano solo sciocchezze, produceva su Kovrin da piccolo un’impressione di fiaba.
Quanti capricci, c’erano, e ricercate mostruosità, quanta natura presa in giro! C’erano spalliere di alberi da frutta, un pero a forma di pioppo cipressino, querce e tigli sferici, una tettoia fatta con un melo, archi, monogrammi, candelabri e persino un 1862 di pruni, cifra che indicava il primo anno in cui Pesockij si era occupato di giardinaggio. Qui capitavano anche begli alberelli proporzionati con i tronchi dritti e forti come palme, e solo dopo averli osservati attentamente si poteva riconoscere in questi alberelli l’uvaspina o il ribes. Ma quello che del frutteto metteva più allegria e che gli dava un aspetto vivace, era il continuo movimento. Dal primo mattino fino a sera vicino agli alberi, ai cespugli, sui vialetti e nelle aiuole, come formiche brulicavano uomini con carriole, zappe, annaffiatoi…
Kovrin arrivò dai Pesockij di sera, dopo le nove. Tanja e suo padre, Egor Semënyč, li trovò in grande ansia. Il cielo limpido, stellato e il termometro preannunciavano una gelata verso mattino, e tra l’altro il giardiniere Ivan Karlyč era andato in città e non c’era nessuno su cui fare affidamento. Durante la cena si parlò solo della gelata mattutina e fu deciso che Tanja non sarebbe andata a dormire e dopo mezzanotte avrebbe fatto un giro in giardino per vedere se era tutto in ordine, mentre Egor Semënyč si sarebbe alzato alle tre o anche prima.
Kovrin passò con Tanja tutta la sera e dopo mezzanotte andò con lei in giardino. Faceva freddo. In cortile c’era già un forte odore di fumo. Nel frutteto grande, che veniva chiamato commerciale e rendeva a Egor Semënyč alcune migliaia di rubli di introiti netti all’anno, a terra si estendeva un fumo nero, denso e acre che, avvolgendo gli alberi, difendeva queste migliaia di rubli dal gelo. Qui gli alberi erano disposti a scacchiera, le loro file erano diritte e regolari come schiere di soldati, e questa regolarità severa e pedante e il fatto che tutti gli alberi fossero della stessa altezza e avessero chiome e tronchi perfettamente identici rendevano il quadro monotono e persino noioso.
Kovrin e Tanja passeggiavano tra le file dove fumigavano i falò di concime, paglia e rifiuti vari, e di tanto in tanto incrociavano lavoranti che si aggiravano nel fumo come fantasmi. Erano in fiore solo i ciliegi, i pruni e alcuni tipi di meli, ma tutto il giardino sprofondava nel fumo, e solo vicino ai vivai Kovrin trasse un respiro a pieni polmoni.
«Fin da piccolo qui starnutivo per il fumo» disse stringendosi nelle spalle
«ma non capisco ancora come questo fumo possa salvare dal gelo.»
«Il fumo sostituisce le nuvole quando non ce ne sono…» rispose Tanja.
«E a cosa servono le nuvole?»
«Quando il tempo è grigio e nuvoloso non ci sono gelate mattutine.»
«Ah, ecco!»
Sorrise e la prese per mano. La sua larga faccia, molto seria, infreddolita con sottili sopracciglia nere, il bavero sollevato del cappotto che le impediva di muovere liberamente la testa, e, tutta lei, magrolina, ben fatta, col vestito sollevato per la rugiada, lo commuoveva.
«Signore, ma è già grande!» disse. «Quando sono partito da qui per l’ultima volta, cinque anni fa, eravate ancora una bambina. Eravate tanto magra, spilungona, senza cappello, portavate un vestitino corto, e io per prendervi in giro vi chiamavo airone… Come passa il tempo!»
«Sì, cinque anni!» sospirò Tanja. «Molta acqua è passata da allora. Ditemi, Andrjuša, in coscienza» disse in fretta guardandolo in faccia «vi sentite lontano da noi? Del resto, perché ve lo chiedo? Siete un uomo, vivete già la vostra vita interessante, siete una celebrità… Estraniarsi è così naturale! Ma comunque sia, Andrjuša, ho voglia che ci consideriate dei vostri. Ne abbiamo il diritto.»
«Per me è così, Tanja.»
«Parola d’onore?»
«Sì, parola d’onore.»
«Oggi vi siete meravigliato che avessimo tante vostre fotografie. Eppure lo sapete che mio padre vi adora. Certe volte mi sembra che voglia più bene a voi che a me. È orgoglioso di voi. Siete uno studioso, un uomo straordinario, avete fatto una carriera brillante, e lui è sicuro che siate riuscito così perché vi ha educato lui. Non gli impedisco di pensarla così. Pazienza.»
Incominciava già l’alba, e lo si notava soprattutto per il particolare nitore con cui si delineavano nell’aria le volute di fumo e le chiome degli alberi. Cantavano gli usignoli, e dai campi giungeva il grido delle quaglie.
«Comunque, è ora di andare a dormire» disse Tanja. «E fa anche freddo.» Lo prese sottobraccio. «Grazie, Andrjuša, di essere arrivato. I nostri conoscenti non sono interessanti, e sono anche pochi. Abbiamo solo il giardino, il giardino, il giardino e nient’altro. Fusto, mezzo fusto» e si mise a ridere, «mele di Oporto, renette, borovinche, inoculazione, innesto…
Tutta, tutta la nostra vita è andata nel giardino, non sogno nemmeno mai null’altro che meli e peri. Certo, è bello, utile, ma a volte viene voglia d’altro per cambiare. Ricordo quando venivate da noi per le vacanze o solo così la casa diventava più fresca e luminosa, come se avessero tolto le fodere da lampadari e mobili. Allora ero una bambina eppure capivo.»
Parlava con grande sentimento. A lui chissà perché venne d’un tratto in mente che durante l’estate avrebbe potuto affezionarsi a questo essere piccolo, debole, loquace, invaghirsi e innamorarsi – nella loro situazione era così possibile e naturale! Questo pensiero lo commosse e lo fece sorridere; si chinò sul viso carino, assorto e canticchiò piano: “Onegin, celato a te non sia, che amo Tat’jana alla follia…”
Quando arrivarono a casa, Egor Semënyč si era già alzato. Kovrin non aveva sonno, si mise a chiacchierare col vecchio e tornò in giardino con lui: Egor Semënyč era alto, aveva spalle larghe, una gran pancia e soffriva di dispnea, ma camminava sempre così in fretta che era difficile stargli dietro. Aveva un’aria oltremodo preoccupata, andava sempre di fretta con il tono di chi pensa che, se arriva un minuto dopo, è la fine.
«Vedi com’è la storia, caro…» cominciò, fermandosi a riprendere fiato.
«Al livello del terreno, come vedi, c’è il gelo, ma se si solleva il termometro su un bastone a tre o quattro metri, è più caldo… Come mai è così?»
«Non lo so davvero» rispose Kovrin e sorrise.
«Hm… Non si può sapere tutto, certo… Per quanto ampia sia la mente, non si riesce a farci entrare tutto. Tu poi non ti occupi sempre più di filosofia?»
«Sì. Insegno psicologia, ma mi occupo più che altro di filosofia.»
«E non ti viene a noia?»
«Al contrario, non vivo d’altro.»
«Speriamo che ti vada sempre così» disse Egor Semënyč, lisciandosi perplesso le fedine canute. «Speriamo… Sono molto contento per te… sono contento, caro…»
Ma d’un tratto tese l’orecchio e, facendo una faccia orribile, corse di lato e presto scomparve dietro gli alberi, tra le nuvole di fumo.
«Chi è che ha legato il cavallo al melo?» si sentì il suo grido disperato, lacerante: «Chi è quel mascalzone e canaglia che ha osato legare il cavallo al melo? Dio mio, Dio mio! Hanno mandato tutto in rovina, fatto gelare tutto, fatto sciupare tutto, fatto guastare tutto! Il frutteto è finito! Il frutteto è distrutto! Dio mio!»
Quando tornò da Kovrin aveva la faccia sfinita, offesa.
«Come si fa con questo popolo infernale?» disse con voce di pianto, allargando le braccia. «Stanotte Stëpka ha portato il concime e ha legato il cavallo al melo! Quel vigliacco ha legato le redini strette strette, e così la corteccia si è scalfita in tre punti. Che roba! Io gli parlo, ma lui, cretino che non è altro, mi fa tanto d’occhi! Impiccarlo è poco!»
Quando si fu tranquillizzato, abbracciò Kovrin e lo baciò su una guancia.
«Oh, speriamo bene,.. speriamo bene…» borbottò. «Sono molto contento che sia venuto. Indicibilmente contento… Grazie.»
Poi, sempre con quella andatura veloce e la faccia preoccupata fece il giro di tutto il frutteto e mostrò al suo ex pupillo tutte le aranciere, le serre, i capanni sotterranei e i suoi due alveari, che chiamava la meraviglia del nostro secolo.
Mentre camminavano, sorse il sole e illuminò il giardino. Venne caldo. Pregustando una giornata limpida, allegra, lunga, a Kovrin venne in mente che era solo l’inizio di maggio e che aveva ancora davanti tutta l’estate, altrettanto limpida, allegra, lunga, e d’un tratto nel cuore gli si mosse il giovanile senso di gioia che provava da bambino quando correva per questo giardino. E fu lui ad abbracciare il vecchio e a baciarlo con tenerezza.
Entrambi, commossi, andarono a casa e si misero a bere il tè da vecchissime tazze di porcellana, con la panna, con grosse paste a otto – e questi piccoli particolari riportarono nuovamente alla mente di Kovrin l’infanzia e la gioventù. Il meraviglioso presente e le impressioni del passato che vi si risvegliavano si confondevano; ne veniva un senso di pienezza eccessiva, però gradevole.
Aspettò che Tanja si svegliasse e insieme con lei prese il caffè, fece due passi, poi andò in camera sua e si mise al lavoro. Leggeva con attenzione, prendeva appunti e di tanto in tanto sollevava gli occhi per guardare fuori delle finestre aperte, oppure i fiori freschi, ancora bagnati di rugiada, sistemati in vasi sulla scrivania, e riabbassava gli occhi al libro, e gli sembrava che in lui ogni venuzza tremasse di piacere, eccitata.
II
In campagna, come in città, continuava a condurre una vita nervosa e inquieta. Leggeva e scriveva molto, studiava l’italiano e, quando faceva una passeggiata, pensava con piacere che presto si sarebbe rimesso al lavoro. Dormiva così poco che tutti si meravigliavano; se per caso di giorno si appisolava mezz’ora, non dormiva poi per tutta la notte e dopo la notte insonne si sentiva rinvigorito e allegro come se nulla fosse.
Parlava molto, beveva vino e fumava sigari costosi. Dai Pesockij venivano spesso, quasi ogni giorno, delle baryšni di possedimenti vicini che insieme a Tanja suonavano il pianoforte e cantavano; a volte veniva un giovanotto, un vicino, che suonava bene il violino. Kovrin non si saziava di ascoltare musica e canto e ne rimaneva spossato, ciò che aveva espressione fisica negli occhi che gli si chiudevano e nella testa che gli ciondolava di lato.
Una volta, dopo il tè della sera, era seduto sulla terrazza a leggere. In soggiorno intanto Tanja soprano, una baryšnja contralto e il giovanotto al violino, provavano la famosa serenata di Braga. Kovrin seguiva le parole (erano russe) e non riusciva affatto a capirne il senso. Finalmente, posato il libro e seguendo con attenzione, capì: una ragazza dalla fantasia malata di notte sentiva in giardino suoni misteriosi, a tal punto belli e strani da considerarli un’armonia sacra, che noi mortali non capiamo, perciò se ne rivola in cielo.
A Kovrin cominciarono a chiudersi gli occhi. Si alzò e, spossato, fece due passi in soggiorno e poi in sala. Quando il canto cessò, prese Tanja sotto braccio e uscì con lei sul terrazzo.
«È da stamattina che ho in testa una leggenda» disse. «Non ricordo dove l’ho letta o sentita, ma è una leggenda strana, che non ha nessun senso. A cominciare dal fatto che non brilla per la sua chiarezza. Mille anni fa un monaco vestito di nero camminava per il deserto, in Siria o in Arabia… Ad alcune miglia da dove camminava, dei pescatori videro un altro monaco nero che si spostava lentamente sulla superficie di un lago. Questo secondo monaco era un miraggio. Ora dimenticate tutte le leggi dell’ottica che la leggenda, a quanto pare, non riconosce, e sentite il seguito.
Dal miraggio si formò un secondo miraggio, poi dal secondo un terzo, e così l’immagine del monaco nero cominciò a essere trasmessa all’infinito da uno strato dell’atmosfera all’altro. Lo videro ora in Africa, ora in Spagna, ora in India, ora all’Estremo Nord… Infine, uscì dai confini dell’atmosfera terrestre e ora vaga per l’universo intero, senza che mai si verifichino le condizioni alle quali potrebbe svanire. Magari, in questo momento lo stanno vedendo su Marte o su una stella della Croce del Sud. Ma, mia cara, la sostanza, il fulcro della leggenda sta nel fatto che mille anni esatti dopo che il monaco ha camminato nel deserto, il miraggio ricadrà nell’atmosfera terrestre e si mostrerà alla gente. E sembra che questi mille anni stiano ormai per scadere… Il senso della leggenda è che il monaco nero ce lo dobbiamo aspettare da un giorno all’altro.»
«Che strano miraggio» disse Tanja, cui la leggenda non era piaciuta.
«Ma quello che è più stupefacente» sorrise Kovrin «è che non riesco affatto a ricordarmi come mi sia venuta in mente questa leggenda. L’ho letta da qualche parte? L’ho sentita? O, forse, il monaco nero me lo sono sognato? Lo giuro su Dio, non mi ricordo. Ma la leggenda mi avvince. È tutto il giorno che ci penso.»
Dopo avere lasciato che Tanja tornasse dagli ospiti, uscì di casa e pensieroso si mise a passeggiare vicino alle aiuole. li sole stava già tramontando. I fiori, dato che li avevano appena innaffiati, emanavano un odore umido, eccitante. In casa ripresero a cantare, e da lontano il violino dava l’impressione di una voce umana. Kovrin, concentrandosi per farsi venire in mente dove aveva sentito o letto la leggenda, si diresse senza fretta verso il parco e senza accorgersene arrivò al fiume.
Seguendo il sentiero che correva lungo la riva scoscesa intorno alle radici nude, scese vicino all’acqua, qui disturbò i chiurli, spaventò due anatre. Sui pini cupi qua e là rilucevano ancora gli ultimi raggi del sole che tramontava, ma sulla superficie del fiume era già sera fatta. Attraverso un ponticello Kovrin passò dall’altra parte.
Davanti a lui ora si estendeva un ampio campo coperto di giovane segale non ancora in fiore. Lontano non ci sono né abitazioni umane né anima viva, e sembra che il sentiero, a imboccarlo, porti in quel luogo ignoto, enigmatico dove il sole è appena andato e il crepuscolo fiammeggia così largo e maestoso.
“Che spazio, che libertà, che silenzio!” pensava Kovrin camminando per il sentiero. “E sembra che tutto il mondo mi guardi, che si sia nascosto e aspetti che io lo capisca…”
Ma ecco che la segale fu attraversata da onde e un lieve venticello serale gli carezzò la testa scoperta. Dopo un attimo un altro colpo di vento, ma più forte, frusciò la segale e da dietro si sentì il sordo fruscio dei pini. Kovrin si fermò sbalordito. All’orizzonte, come un vortice o una tempesta, si stava alzando dalla terra al cielo un’alta colonna nera. Non aveva contorni nitidi, ma fin dal primo attimo si capiva che non restava ferma, ma che si muoveva a una velocità terrificante, stava venendo proprio qui, dritta contro Kovrin e più si avvicinava più si faceva piccola e nitida. Kovrin si buttò di lato, nella segale, per farla passare, e fece appena in tempo a farlo…
Un monaco vestito di nero, con la testa canuta e le sopracciglia nere, le braccia incrociate sul petto, gli sfrecciò accanto… I suoi piedi nudi non toccavano terra. Proseguendo cinque o sei metri, si voltò a guardare Kovrin, gli fece un cenno con la testa e un sorriso tenero e allo stesso tempo giocoso. Ma che faccia pallida, spaventosamente pallida, magra! Ricominciando a salire, superò il fiume, urtò senza fare rumore contro la riva argillosa e i pini e, passandovi attraverso, si dissolse come fumo.
«Ecco, vedete…» borbottò Kovrin. «Quindi c’è del vero nella leggenda.»
Senza cercare di spiegarsi lo strano fenomeno, contento già di aver potuto vedere così da vicino e tanto nitidamente
non solo il vestito nero, ma perfino la faccia e gli occhi del monaco, piacevolmente turbato, tornò a casa.
Nel parco e in giardino la gente passeggiava tranquilla, a casa suonavano: quindi lui solo aveva visto il monaco.
Aveva una gran voglia di raccontare tutto a Tanja e a Egor Semënyč, ma si rese conto che probabilmente avrebbero preso le sue parole per un delirio, e questo li avrebbe spaventati; meglio star zitto. Rideva forte, cantava, ballava la mazurka, era allegro e tutti, gli ospiti e Tanja, trovavano che oggi avesse una faccia particolare,
raggiante, ispirata, e che fosse molto interessante.
III
Dopo cena, quando se ne andarono gli ospiti, andò in camera sua e si sdraiò sul divano: aveva voglia di pensare al monaco. Ma dopo un attimo entrò Tanja.
«Ecco, Andrjuša, leggete gli articoli di mio padre» disse porgendogli un fascicolo di opuscoli e di articoli rilegati. «Articoli meravigliosi. Scrive ottimamente.»
«Ottimamente, allora!» disse Egor Semënyč entrando dietro di lei con un sorriso sforzato; si vergognava. «Non dar retta, per favore, non leggerli! Se però ti vuoi addormentare, leggili pure: sono un ottimo sonnifero.»
«Secondo me, sono articoli fantastici» disse Tanja profondamente convinta. «Leggeteli, Andriuša, e persuadete papà a scrivere più spesso. Potrebbe scrivere un intero trattato di frutticoltura.»
Egor Semënyč fece una risata sforzata, arrossì e si mise a dire le frasi che dicono di solito gli autori imbarazzati. Finalmente cominciò a cedere.
«Allora leggi prima l’articolo di Hoche e questi articoletti russi» borbottò sfogliando gli opuscoli con mani tremanti, «se no non capisci. Prima di leggere le mie obiezioni, bisogna sapere su cosa ho da obiettare. Comunque, sono sciocchezze… roba noiosa. Poi è ora di dormire, mi pare.»
Tanja uscì. Egor Semënyč si sedette sul divano accanto a Kovrin e fece un sospiro profondo:
«Sì, caro mio…» cominciò dopo un po’ di silenzio. «È così, caro il mio professore. Come vedi scrivo articoli, partecipo a mostre, ricevo medaglie… Le mele di Pesockij, dicono, sono grosse come teste e Pesockij, dicono, col suo frutteto ha accumulato una fortuna. Insomma, “ricco e in gamba è Kočubej”. Ma mi domando: a che scopo? Il frutteto, effettivamente, è splendido, esemplare… Non è un frutteto, ma una vera istituzione di grande importanza nazionale, perché per così dire è un passo avanti verso la nuova era dell’economia russa e dell’industria russa. Ma a che scopo? Che senso ha?»
«È un’impresa che si giustifica da sola.»
«Non è in quel senso. Voglio dire: cosa sarà del frutteto, quando sarò morto? Così come lo vedi ora, senza di me non resisterebbe nemmeno un mese.
Tutto il segreto del successo non sta nel fatto che il frutteto è grande e che ci sono molti lavoranti, ma che io amo questo lavoro – capisci? – forse lo amo più di me stesso. Guardami: faccio tutto io. Lavoro dal mattino alla sera. Tutti gli innesti li faccio io, la potatura io, i trapianti io, tutto io. Quando mi aiutano, sono geloso e mi indispettisco tanto da essere scortese.
Tutto il segreto è nell’amore, nell’occhio vigile del padrone, e nelle mani del padrone, e nella sensazione, quando vai in visita per un’oretta, stai là, ma il cuore non è tranquillo, non sei a tuo agio: hai paura che succeda qualcosa nel frutteto. Quando invece sarò morto, chi ci guarderà? Chi lavorerà? Il giardiniere? I braccianti? Loro? Sai cosa ti dico, allora, caro amico: il nemico numero uno nel nostro lavoro non è la lepre non è il maggiolino e non è il gelo, ma gli altri.»
«E Tanja?» domandò Kovrin sorridendo. «Non è possibile che sia più dannosa della lepre. Lei ama e capisce l’azienda.»
«Sì, la ama e la capisce. Se dopo la mia morte le toccherà il frutteto e sarà la padrona, certo, non potrei desiderare di meglio. Ma se, Dio non voglia, si sposasse?» sussurrò Egor Semënyč guardando spaventato Kovrin.
«È questo il punto! Si sposerà, verranno i figli, al frutteto qui non avrà tempo di pensare. Più di tutto ho paura di questo: sposerà un giovanotto, e quello, avido, darà il frutteto in affitto alle donne del mercato, e tutto andrà al diavolo fin dal primo anno! Nel nostro lavoro le babe sono il castigo di Dio!»
Egor Semënyč fece un sospiro e tacque un po’. «Sarà anche egoismo, ma lo dico con sincerità: non voglio che Tanja si sposi. Ho paura! Qui da noi viene un dandy col violino e lo gratta; so che Tanja non lo sposerà, lo so bene, ma non lo posso vedere! Nel complesso, mio caro, sono un bel bi- slacco. Confesso.»
Egor Semënyč si alzò e si mise a camminare agitato per la stanza, e si vedeva che voleva dire qualcosa di molto importante, ma non si decideva.
«Ti voglio molto bene e ti parlerò con franchezza» si decise infine, infilandosi le mani in tasca. «Verso certe questioni delicate ho un atteggiamento semplice e dico quel che penso dritto in faccia, e non posso sopportare i cosiddetti pensieri reconditi. Te lo dico dritto in faccia: sei l’unico uomo al quale non avrei paura di far sposare mia figlia. Sei una persona intelligente, di cuore, e non lasceresti andare il mio amato frutteto. Ma la ragione principale è che ti amo come un figlio… e sono fiero di te. Se fra te e Tanja nascesse una storia, come dire? ne sarei molto contento, anzi felice. Te lo dico dritto in faccia, senza affettazione, da persona onesta.»
Kovrin sorrise. Egor Semënyč aprì la porta per uscire, e si fermò sulla soglia.
«Se a te e Tanja nascesse un figlio, ne farei un frutticoltore» disse, dopo averci pensato su. «A ogni modo, è un sogno vano… Buona notte.»
Rimasto solo, Kovrin assunse una posizione più comoda e si dedicò agli articoli.
Uno aveva come titolo Sulle colture intermedie, un altro: Alcune parole sull’osservazione del signor Z. sulla rivangatura del terreno di un frutteto nuovo, un terzo: Ancora sull’inoculazione a occhio dormiente, e così via. Ma che tono inquieto, irregolare, che fervore nervoso, quasi morboso!
Ecco l’articolo, a quanto pare, dal titolo più pacifico e dal contenuto più indifferente: vi si parla del melo Antonovka. Ma Egor Semënyč comincia “audiatur altera pars” e conclude “sapienti sat”, e fra queste citazioni tutta una sequela di varie parole velenose all’indirizzo dell’“ignoranza scientifica dei nostri signori frutticoltori patentati, che osservano la natura dall’alto delle loro cattedre”, o del signor Hoche, “il cui successo si fonda su profani e dilettanti”, e sempre qui a sproposito il prolungato e insincero rimpianto che non si possano più frustare i mugikì che rubano la frutta danneggiando gli alberi.
“È un’attività bella, carina, sana, ma anche qui ci sono passioni e guerre” pensò Kovrin. “A quanto pare, dovunque, in tutti i campi gli idealisti sono nervosi e particolarmente sensibili. È probabile che debba essere così.”
Gli venne in mente Tanja, alla quale piacevano tanto gli articoli di Egor Semënyč. Di bassa statura, pallida, così magra che le si vedono le clavicole; gli occhi molto aperti, scuri, intelligenti, sempre assorti alla ricerca di qualcosa: l’andatura come il padre, a passi piccoli, affrettati. Parla molto, le piace discutere, e nel farlo anche la frase più insignificante è accompagnata da una mimica espressiva e da gesti. Sommamente nervosa, a quanto pare.
Kovrin si mise a leggere il seguito, ma non capiva niente e smise. Una gradevole eccitazione, la stessa di quando aveva ballato la mazurka e ascoltato la musica, ora lo tormentava e suscitava in lui una quantità di pensieri. Si alzò e si mise a camminare per la stanza, pensando al monaco nero. Gli venne in mente che se quello strano, sovrannaturale monaco l’aveva visto solo lui, voleva dire che era malato già al punto di soffrire di allucinazioni. Questo ragionamento lo spaventò, ma non per molto. “Eppure sto bene, e non faccio del male a nessuno; quindi nelle mie allucinazioni non c’è niente di brutto” pensò, e di nuovo si sentì bene.
Si sedette sul divano e si prese la testa fra le mani, trattenendo l’incomprensibile gioia che aveva riempito tutto il suo essere, poi si rimise a camminare e si sedette al lavoro. Ma i pensieri che leggeva dal libro non lo soddisfacevano. Aveva voglia di qualcosa di gigante, imprendibile, stupefacente. Verso mattino si spogliò e di malavoglia andò a letto: bisognava pur dormire! Quando si sentirono i passi di Egor Semënyč che usciva in giardino, Kovrin suonò e ordinò al cameriere di portargli del vino. Con piacere bevve alcuni bicchierini di Lafitte, poi si coprì anche la testa; la coscienza gli si annebbiò, e si addormentò.
IV
Egor Semënyč e Tanja litigavano spesso e si dicevano brutte cose.
Un mattino attaccarono briga. Tanja scoppiò in lacrime e se ne andò in camera sua. Non uscì né a pranzo né a bere il tè. Egor Semënyč all’inizio camminava solenne, tronfio, come per far capire che per lui gli interessi della giustizia e dell’ordine erano più importanti di tutto al mondo, ma presto non resse la parte e si lasciò abbattere.
Vagava triste per il parco e continuava a sospirare: «Ah, Dio mio, Dio mio!», e a pranzo non mangiò nemmeno una briciola. Alla fine, sentendosi in colpa, tormentato dalla coscienza, bussò alla porta chiusa e chiamò timido:
«Tanja! Tanja!»
E in risposta a lui da dietro la porta si sentì la voce debole, sfinita dalle lacrime e nello stesso tempo decisa:
«Lasciatemi, ve ne prego.»
L’ angustia dei padroni si rifletteva su tutta la casa, persino sugli uomini che lavoravano nel frutteto. Kovrin era immerso nel suo lavoro interessante, ma verso la fine anche lui cominciò ad annoiarsi e a sentirsi a disagio. Per dissipare in qualche modo il malumore generale, decise di intromettersi e verso sera bussò da Tanja. Pote entrare.
«Ohi ohi, che vergogna!» cominciò per scherzo, guardando stupefatto la faccia addolorata, bagnata di lacrime, coperta di macchie rosse di Tanja.
«Possibile che sia tanto grave? Ohi ohl!»
«Ma sapeste Come mi tormenta!» rispose, e le lacrime, le lacrime ardenti, abbondanti, le sgorgarono dai grandi occhi. «Mi ha tormentato!» continuò torcendosi le mani. «Io non gli ho detto nulla… nulla… Ho detto soltanto che non c’è necessità di tenere… lavoranti in più se… se in qualsiasi momento, si può prendere dei giornalieri. Infatti… infatti i lavoranti è già una settimana intera che non fanno niente… Io… io ho detto solo questo, e lui si è messo a urlare e mi ha detto… molte parole offensive, profondamente ingiuriose. Per cosa?»
«Basta, basta» disse Kovrin sistemandole i capelli. «Vi siete insultati, avete pianto e basta. Non bisogna prendersela così a lungo, non va bene… tanto più che ha un amore senza fine per voi.»
«Lui mi… mi ha rovinato tutta la vita» continuò Tanja, singhiozzando.
«Non faccio che sentire umiliazioni e… e offese. Mi considera di troppo in casa sua. D’altra parte… ha ragione. Domani me ne vado, prendo un posto di telegrafista… Pazienza…»
«Su su su… Non dovete piangere, Tanja. Non dovete, cara… Siete tutti e due suscettibili, irascibili, e la colpa è di tutti e due. Andiamo, vi faccio rappacificare.»
Kovrin parlava tenero e persuasivo, mentre lei continuava a piangere, le spalle frementi e i pugni stretti, come se davvero le fosse capitata una disgrazia terribile.
A lui faceva ancora più pena perché il suo dolore non era grave, eppure soffriva profondamente. Bastavano proprio delle sciocchezze per rendere infelice questa creatura per tutto il giorno, o magari per tutta la vita! Consolando Tanja, Kovrin pensava che, a parte questa ragazza e suo padre, nemmeno col lanternino in pieno sole in tutto il mondo avrebbe potuto trovare persone che lo amassero come uno di loro, come uno di famiglia; senza quelle due persone magari lui, che aveva perso padre e madre nella prima infanzia, fino alla morte non avrebbe mai saputo cos’è la tenerezza sincera e quell’amore ingenuo, non razionale, che si ha solo per gli intimi, le persone di famiglia.
E sentì che ai suoi nervi un po’ malati, tesi, come un ferro alla calamita, rispondevano i nervi di questa ragazza in lacrime, fremente. Non avrebbe mai potuto amare una donna sana, forte, con le guance rosee, ma la pallida, debole, infelice Tanja gli piaceva. E le accarezzava volentieri i capelli e le spalle, le stringeva le mani e le asciugava le lacrime…
Finalmente smise di piangere. Si lamentò ancora un pezzo del padre e della propria vita pesante, insopportabile in questa casa, supplicando Kovrin di mettersi nei suoi panni; poi a poco a poco cominciò a sorridere e a sospirare che Dio le aveva dato un carattere così brutto e, alla fin fine, con un forte sorriso si diede della stupida e corse fuori dalla stanza.
Quando, poco dopo, Kovrin uscì in giardino, Egor Semënyč e Tanja come se nulla fosse stavano già camminando accanto lungo il vialetto e mangiavano tutti e due pane di segale col sale, perché tutti e due avevano
fame.
V
Soddisfatto che gli fosse riuscito così bene il ruolo di paciere, Kovrin andò nel parco. Seduto su una panchina a pensare, sentì il fragore delle carrozze e una donna che rideva: arrivavano ospiti. Quando le ombre della sera cominciarono a calare sul giardino, si sentirono indistinti i suoni di un violino, le voci che cantavano, e questo gli fece venire in mente il monaco nero. Dove, in che paese o su quale pianeta gira in questo momento questa insensatezza ottica?
Si era appena ricordato della leggenda, disegnato mentalmente quella scura visione che aveva visto nel campo di segale, quando da dietro un pino proprio di fronte uscì silenzioso, senza il minimo fruscio, un uomo di media statura con la testa canuta scoperta, tutto vestito di scuro e a piedi nudi che sembrava un mendicante, e sulla sua faccia pallida come un morto risaltavano marcate le sopracciglia nere. Facendo un cenno di saluto con la testa, questo mendicante o viandante si avvicinò alla panchina senza fare rumore e vi si sedette, e Kovrin riconobbe in lui il monaco nero. Per un minuto tutti e due si osservarono: Kovrin con stupore, il monaco con tenerezza e, come allora, un po’ giocoso, con un’aria furba.
«Devi essere un miraggio» disse Kovrin. «Perché poi te ne stai qui fermo seduto? La leggenda è diversa.»
«È lo stesso» rispose il monaco non sùbito, piano, girando la faccia verso di lui. «La leggenda, il miraggio e io, tutto questo è un prodotto della tua immaginazione eccitata. Sono un fantasma.»
«Quindi, non esisti?» chiese Kovrin.
«Pensala come ti pare» rispose il monaco e fece un lieve sorriso. «Esisto nella tua immaginazione, e la tua immaginazione fa parte della natura, quindi esisto anche in natura.»
«Hai una faccia molto vecchia, intelligente e moltissimo espressiva, proprio come se vivessi davvero da più di mille anni» disse Kovrin. «Non sapevo che la mia immaginazione fosse in grado di creare fenomeni del genere. Ma perché mi guardi con tanto entusiasmo? Ti piaccio?»
«Sì. Sei uno dei pochi che si possono giustamente chiamare eletti da Dio. Sei al servizio della verità eterna. I tuoi pensieri, le tue intenzioni, i tuoi studi sorprendenti e tutta la tua vita portano un’impronta divina, celeste, poiché sono dedicati al razionale e al bello, ossia a ciò che è eterno.»
«Hai detto: verità eterna… Ma è accessibile e necessaria, agli uomini, la verità eterna, se la vita eterna non esiste?»
«La vita eterna esiste» disse il monaco.
«Tu credi nell’immortalità degli uomini?»
«Sì, certo. Un grandioso, brillante futuro aspetta voi uomini. E più sulla terra ci sono uomini come te, prima si realizzerà questo futuro. Senza di voi, al servizio del principio supremo, che vivete con coscienza e libertà, l’umanità sarebbe insignificante; sviluppandosi in modo naturale, aspetterebbe ancora a lungo la fine della propria storia terrestre. Voi invece la fate entrare con qualche migliaio d’anni di anticipo nel regno della verità eterna – e in questo sta il vostro grande merito. Voi incarnate la benedizione divina che riposa negli uomini.»
«E qual è il fine della vita eterna?» chiese Kovrin.
«Come di tutte le vite: il piacere. Il piacere autentico sta nella conoscenza, e la vita eterna offre innumerevoli e inesauribili fonti di conoscenza, in questo senso è scritto: nella casa del Padre mio vi sono molti posti.»
«Se tu sapessi com’è piacevole starti a sentire!» disse Kovrin sfregandosi le mani dalla soddisfazione.
«Sono molto contento.»
«Ma lo so: quando te ne andrai, la questione della tua essenza non mi darà pace. Sei un fantasma, un’allucinazione. Quindi sono malato di mente, anormale?»
«E se fosse. Non c’è da essere imbarazzati. Sei malato perché hai lavorato al di là delle tue forze e ti sei esaurito, e quindi hai sacrificato la tua salute all’idea ed è vicino il tempo in cui le darai la vita stessa. Cosa c’è di meglio? È l’aspirazione di tutte le nature nobili che hanno doti celesti.»
«Se so di essere malato di mente, posso credere in me stesso?»
«Ma come fai a sapere che le persone geniali a cui crede tutto il mondo non abbiano visto fantasmi anche loro? Ora gli scienziati dicono che il genio sia affine alla follia. Amico mio, sani e normali sono solo i mediocri, che stanno in mezzo al branco. Le riflessioni sull’epoca delle malattie nervose, del sovraffaticamento, della degenerazione e così via possono mettere in seria agitazione solo chi vede lo scopo della vita nel presente, cioè quelli che stanno nel branco.»
«I romani dicevano: mens sana in corpore sano.»
«Non tutto quello che dicevano i romani o i greci è vero. L’animazione, l’eccitazione, l’estasi: tutto quello che distingue i profeti, i poeti, chi soffre per un’idea, dagli uomini normali è l’opposto dell’aspetto animalesco dell’uomo, cioè della sua salute fisica. Ripeto: se vuoi essere sano e normale, entra nel branco.»
«È strano, ripeti quello che spesso viene in mente a me» disse Kovrin.
«Sembra che abbia spiato, origliato i miei pensieri reconditi. Ma non parliamo di me. Cosa intendi per verità eterna?»
Il monaco non rispose. Kovrin lo fissò e non ne distinse la faccia: i suoi lineamenti si annebbiavano e si dissolvevano. Poi al monaco cominciarono a sparire la testa, le braccia; il suo torso si confondeva con la panchina e con il crepuscolo, e scomparve del tutto.
«L’allucinazione è finita?» si disse Kovrin e sorrise. «Che peccato!»
Tornò indietro a casa allegro e felice. Quel poco che gli aveva detto il monaco nero lusingava non l’amor proprio ma tutto il suo animo, tutto il suo essere. Essere un eletto, al servizio della verità eterna, essere tra quelli che renderanno con alcune migliaia d’anni d’anticipo l’umanità degna del regno di Dio, ossia eviteranno agli uomini altre migliaia d’anni di lotta, di peccato e di sofferenze, sacrificare all’idea tutto: gioventù, forze, salute, essere pronto a morire per il bene comune: che elevato, che fortunato destino!
Gli si risvegliò nella memoria il passato, puro, integro, pieno di lavoro, gli venne in mente quello che aveva imparato, e insegnato lui stesso agli altri, e si accorse che le parole del monaco non erano esagerate.
Incontro nel parco gli veniva Tanja. Aveva già un altro vestito:
«Siete qui?» disse. «E noi che vi cerchiamo, vi cerchiamo… Ma che avete?» si stupì dando un’occhiata alla sua faccia entusiasta, splendente e agli occhi pieni di lacrime. «Come siete strano, Andrjuša.»
«Sono soddisfatto, Tanja» rispose Kovrin, mettendole le mani sulle spalle.
«Sono più che soddisfatto, sono felice! Tanja, cara Tanja, mi siete simpatica in modo straordinario. Cara Tanja, sono così contento, così contento!»
Le baciò con ardore entrambe le mani e continuò:
«Ho appena vissuto momenti luminosi, magici, non terreni. Ma non posso raccontarvi tutto perché mi prendereste per matto o non mi credereste. Parliamo di voi. Cara, bella Tanja! Io vi amo e mi sono già abituato ad amarvi. La vostra vicinanza, incontrarvi dieci volte al giorno sono diventati una mia esigenza intima. Non so come farò senza di voi quando me ne tornerò a casa.»
«Macché!» sorrise Tanja. «Vi dimenticherete di noi dopo due giorni. Noi siamo gente piccola, voi invece siete un grand’uomo.»
«No, parliamone sul serio!» disse. «Vi porto con me, Tanja. Eh? Ci venite con me? Volete essere mia?»
«Macché!» disse Tanja e voleva di nuovo sorridere, ma il riso non le uscì e in faccia le comparvero delle macchie rosse.
Si mise a respirare veloce e s’incamminò in fretta in fretta, non verso casa però, ma nel folto del parco.
«Non ci avevo pensato… non ci pensavo!» disse stringendo le mani come disperata.
Kovrin invece le andava dietro e le diceva sempre con quella faccia splendente, entusiasta:
«Voglio un amore che mi prenda tutto, e questo amore solo voi, Tanja, potete darmelo. Sono felice! Felice!»
Era stupefatta, china, corrucciata e come invecchiata di dieci anni, mentre lui la trovava stupenda ed esprimeva forte il suo entusiasmo:
«Com’è bella!»
VI
Saputo da Kovrin che non solo era nata una storia, ma che ci sarebbero state anche le nozze, Egor Semënyč si mise a camminare a lungo da un angolo all’altro, cercando di nascondere l’agitazione. Cominciarono a tremargli le mani, il collo gli si gonfiò e si fece di porpora, diede ordine di attaccare la carrozzella da corsa e se ne andò. Tanja, vedendo come frustava il cavallo e quanto si era calcato il berretto, quasi sulle orecchie, capì il suo umore, si chiuse in camera e pianse tutto il giorno.
Nelle aranciere erano già maturate pesche e prugne; l’imballaggio e la spedizione a Mosca di questo carico delicato ed enigmatico richiedeva molta attenzione, fatica e preoccupazioni. Poiché l’estate era molto calda e secca, era necessario annaffiare ogni albero, il che richiedeva molto tempo e molta mano d’opera, ed erano comparsi molti bruchi, che i lavoranti e persino Egor Semënyč e Tanja, con grande disgusto di Kovrin, schiacciavano direttamente con le dita. Con tutto questo bisognava già prendere le ordinazioni di frutta e alberi per l’autunno e tenere una intensa corrispondenza.
E nel momento più caldo, quando sembrava che nessuno avesse un momento libero, vennero i lavori nei campi che sottrassero al frutteto più di metà dei lavoranti: Egor Semënyč, molto abbronzato, tormentato, cattivo, correva ora nel frutteto, ora nei campi e gridava che lo stavano facendo a pezzi e che si sarebbe piantato una pallottola in fronte.
E questa volta c’era anche il daffare per la dote, alla quale i Pesockij davano non poca importanza; il tintinnio delle forbici, il rombo delle macchine da cucire, l’odore di bruciato dei ferri da stiro e i capricci della modista, una signora nervosa, permalosa, facevano girare la testa a tutti.
E, come facessero apposta, ogni giorno venivano ospiti a cui bisognava offrire intrattenimenti, da mangiare e perfino una sistemazione per la notte. Ma tutti questi lavori forzati passarono impercettibilmente, come nella nebbia. Tanja si sentiva come se l’amore e la felicità l’avessero colta di sorpresa, anche se da quando aveva quattordici anni chissà perché era sicura che Kovrin avrebbe sposato proprio lei. Era stupefatta, non si capacitava, non credeva a se stessa… Ora l’invadeva all’improvviso una tale gioia che le veniva voglia di volarsene sotto le nuvole e là di pregare Dio, ora invece all’improvviso le veniva in mente che in agosto le sarebbe toccato separarsi dal nido dov’era nata e lasciare il padre, oppure, sa Dio come, le veniva l’idea d’essere insignificante, piccina e indegna di un grand’uomo come Kovrin, – e se ne andava in camera, si chiudeva a chiave e piangeva amaramente per alcune ore di seguito.
Quando ci sono ospiti, all’improvviso le sembra che Kovrin sia straordinariamente bello e che di lui siano innamorate tutte le donne e la invidino, e l’animo le si riempie di entusiasmo e di orgoglio, come se avesse vinto il mondo intero, ma basta che lui sorrida per cortesia a una baryšnja, che lei già freme di gelosia, se ne va in camera: e ancora lacrime. Queste nuove sensazioni se la appropriavano del tutto, lei aiutava macchinalmente il padre e non faceva caso né alle pesche, né ai bruchi, né ai lavoranti, né a come correva il tempo.
A Egor Semënyč succedeva quasi lo stesso. Lavorava dal mattino alla notte inoltrata, era sempre di fretta, usciva di sé, si arrabbiava ma tutto in una specie di dormiveglia magico. In lui erano quasi due persone: uno era il vero Egor Semënyč che, ascoltando il giardiniere Ivan Karlyč che gli riferiva certi inconvenienti, si esasperava e si afferrava disperato la testa, e un altro, non vero, mezzo ubriaco, che all’improvviso interrompeva a metà parola una conversazione d’affari, toccava la spalla a un frutticoltore e si metteva a borbottare:
«Checché se ne dica, il sangue conta molto. La madre di lui era una donna stupefacente, nobilissima, intelligentissima. Era un piacere guardare la sua faccia buona, brillante, pura, come un angelo. Disegnava benissimo, scriveva poesie, parlava cinque lingue straniere, cantava… Poveretta, a lei il Regno dei Cieli, è morta di tubercolosi.»
Il falso Egor Semënyč sospirava e, dopo un po’ di silenzio, proseguiva:
«Quando era piccolo e cresceva da me, aveva la stessa faccia d’angelo, serena e buona. Ha lo sguardo, i movimenti, il modo di parlare teneri ed eleganti come sua madre. E l’intelligenza? Ci ha sempre colpito per la sua intelligenza. D’altra parte, non a caso è professore! Non a caso! E vedrai, Ivan Karlyč, cosa ne sarà tra una decina d’anni! Un personaggio irraggiungibile!»
Ma qui il vero Egor Semënyč, riprendendosi, faceva una faccia spaventosa, si prendeva la testa tra le mani e gridava:
«Diavoli! Hanno mandato tutto in rovina, fatto sciupare tutto, fatto gelare tutto! Il frutteto è finito! Il frutteto è distrutto!»
Kovrin invece lavorava con il solito zelo e non faceva caso al viavai. L’amore aveva solo gettato olio sul fuoco. Ogni volta che vedeva Tanja, dopo felice, entusiasta, se ne andava in camera e con la stessa passione con cui aveva appena baciato Tanja e le aveva detto il suo amore si metteva davanti al libro o al suo manoscritto.
Quello che aveva detto il monaco nero sugli eletti da Dio, sulla verità eterna, sul brillante futuro dell’umanità e così via attribuiva al suo lavoro un significato speciale, straordinario e gli riempiva l’animo di orgoglio, di consapevolezza del proprio alto livello. Una o due volte alla settimana, nel parco o a casa, incontrava il monaco nero e conversava a lungo con lui, cosa che però non lo spaventava ma, al contrario, lo lasciava ammirato, dato che ormai era fermamente convinto che visioni simili visitassero solo uomini eletti, distinti, che si sono dedicati al servizio dell’idea.
Un giorno il monaco comparve durante il pranzo e si sedette in sala da pranzo vicino alla finestra. Kovrin se ne rallegrò e con molta abilità intavolò una conversazione con Egor Semënyč e Tanja che potesse interessare il monaco; il nero ospite ascoltava e faceva cenni cortesi con la testa, e anche Egor Semënyč e Tanja ascoltavano e sorridevano allegri, senza sospettare che Kovrin stesse parlando non con loro, ma con la propria allucinazione.
Si avvicinò impercettibilmente il digiuno dell’Assunzione, e subito dopo anche il giorno delle nozze che, per insistente desiderio di Egor Semënyč, furono “crepitanti”, ossia gozzovigliarono disordinatamente per due giorni.
Mangiarono e bevvero per tre o quattromila rubli, ma per via della brutta musica dell’orchestrina, dei brindisi urlanti e del viavai dei camerieri, per via del baccano e della ressa non capirono il gusto né dei vini costosi, né degli strepitosi antipasti ordinati da Mosca.
VII
Una delle lunghe notti invernali Kovrin era a letto e leggeva un romanzo francese. La povera Tanja, a cui di sera veniva mal di testa perché non era abituata a vivere in città, dormiva già da un pezzo e ogni tanto nel delirio pronunciava frasi sconnesse.
Batterono le tre. Kovrin spense la candela e si sdraiò; rimase la lungo sdraiato con gli occhi chiusi, ma non riusciva ad addormentarsi perché gli sembrava che in camera facesse molto caldo e Tanja delirava. Alle quattro e mezza accese la candela e in quel momento vide il monaco nero, che era seduto in poltrona vicino al letto.
«Ciao» disse il monaco e, dopo un po’ di silenzio, domandò: «A cosa pensi?».
«Alla gloria» rispose Kovrin. «Nel romanzo francese che leggevo ora c’è un uomo, un giovane studioso, che fa sciocchezze e si affligge dall’angoscia per la gloria. A me questa angoscia è incomprensibile.»
«Perché sei intelligente. Tu alla gloria sei indifferente come a un giocattolo che non ti coinvolge.»
«Sì, è vero.»
«La notorietà non ti attira. Che cosa c’è di allettante, o di divertente, o di edificante nel fatto che incidano il tuo nome sul monumento funebre e che poi il tempo corroda questa iscrizione insieme alla doratura? E poi, per fortuna, siete in troppi perché la debole memoria umana possa ritenere i vostri nomi.»
«Capisco» concordò Kovrin. «E perché poi ricordarli? Ma parliamo d’altro. Per esempio, della felicità. Che cos’è la felicità?»
Quando l’orologio batté le cinque, era seduto sul letto, le gambe sul tappeto, e diceva rivolto al monaco:
«Nell’antichità un uomo felice finì per aver paura della propria felicità – tanto era grande! – e, per propiziarsi gli dèi, portò loro in sacrificio il suo anello preferito. Lo sai, anche me, come Policrate, comincia un po’ a inquietare la mia felicità. Mi sembra strano di provare dal mattino alla notte solo gioia, mi riempie tutto e ottunde tutti gli altri sentimenti. Non so cosa sia la malinconia, la tristezza o l’angoscia. Come ora che non dormo, ho l’insonnia, ma non mi angoscio. Dico sul serio: comincio a non capacitarmene.»
«Ma perché?» si stupì il monaco. «La gioia è forse un sentimento sovrannaturale? Non deve essere la condizione normale dell’uomo? Più è elevato lo sviluppo intellettuale e morale di un uomo, più è libero, più piacere gli dà la vita. Socrate, Diogene e Marco Aurelio provavano gioia, non tristezza. Anche l’apostolo dice: Rallegratevi sempre8. Quindi rallegrati e sii felice.»
«Ma se gli dèi s’arrabbiano?» scherzò Kovrin e sorrise. «Se mi tolgono i comfort e mi fanno soffrire il freddo e la fame, sarà difficile che sia di mio gusto.»
Tanja intanto si era svegliata e con stupore e orrore guardava il marito. Parlava rivolto alla poltrona, gesticolava e rideva: gli brillavano gli occhi e nel riso c’era qualcosa di strano.
«Andrjuša, con chi stai parlando?» domandò, prendendolo per il braccio che protendeva verso il monaco. Andrjuša! Con chi?
«Eh? Con chi?». Kovrin era imbarazzato. «Ma con lui… È seduto lì» disse indicando il monaco nero.
«Qui non c’è nessuno… nessuno! Andrjuša, sei malato!»
Tanja abbracciò il marito e si strinse a lui, come difendendolo dalle visioni, e gli chiuse gli occhi con la mano.
«Sei malato!» si mise a singhiozzare tremando con tutto il corpo.
«Scusami, caro, ma l’ho notato da un pezzo che sei sconvolto da qualcosa… Sei malato di mente, Andrjuša…»
Il tremito di lei si comunicò anche a lui. Lanciò un’altra occhiata alla poltrona, che ormai era vuota, sentì improvvisamente una debolezza alle braccia e alle gambe, si spaventò e si mise a vestirsi.
«Non è niente, Tanja, non è niente…» borbottava tremando.
«Effettivamente sono un po’ malato… è ora che lo riconosca.»
«L’ho notato già da un pezzo… anche papà l’ha notato» disse, cercando di trattenere i singhiozzi. «Tu parli da solo, sorridi in modo strano… non dormi. Oh, Dio, Dio mio, salvaci!» disse terrorizzata. «Ma tu non avere paura, Andrjuša, non avere paura, in nome di Dio, non avere paura…»
Anche lei si mise a vestirsi. Solo ora, guardandola, Kovrin capì tutta la pericolosità della propria situazione, capì cosa volevano dire il monaco nero e le conversazioni con lui. Gli era ormai chiaro di essere pazzo.
Tutti e due, senza sapere perché, si vestirono e andarono in sala: lei davanti, lui dietro. Qui, svegliato dai singhiozzi, in vestaglia e con la candela in mano era Egor Semënyč, che era loro ospite.
«Non avere paura, Andrjuša» diceva Tanja tremando come per la febbre,
«non avere paura… Papà, passerà tutto… passerà tutto…»
Kovrin non riusciva a parlare dall’agitazione. Voleva dire al suocero in tono scherzoso:
«Fatemi i complimenti, a quanto pare sono uscito di senno» ma mosse solo un po’ le labbra e fece un sorriso amaro.
Alle nove del mattino gli misero cappotto e pelliccia, lo avvolsero in uno scialle e lo portarono in carrozza dal dottore. Cominciò a curarsi.
VIII
Venne di nuovo l’estate, e il dottore gli ordinò di andare in campagna. Kovrin era già guarito, aveva smesso di vedere il monaco nero, e gli restava solo da recuperare le forze fisiche. Dal suocero in campagna, beveva molto latte, lavorava soltanto due ore al giorno, non beveva vino e non fumava.
Il 19 luglio, vigilia di Sant’Il’ja, la sera, in casa, si celebrò il vespro. Quando il cantore porse l’incensiere al pope, la vecchia enorme sala odorò come di cimitero, e Kovrin si annoiava. Uscì in giardino. Senza far caso ai fiori lussureggianti, passeggiò un po’ per il giardino, si sedette su una panchina, poi attraversò il parco; arrivando al fiume, scese e qui rimase sprofondato nei pensieri, guardando l’acqua. I cupi pini con radici pelose che l’anno prima lo avevano visto qui così giovane, gioioso ed energico, ora non sussurravano, ma stavano immobili e muti, come se non lo riconoscessero. Ed effettivamente, i bei capelli lunghi non c’erano più, erano tagliati a spazzola, aveva un’andatura inerte, la faccia, rispetto all’anno prima, era più piena, più pallida.
Attraverso il ponticello passò sull’altra riva. Là dove l’anno prima c’era la segale ora c’erano file di avena falciata. Il sole era già tramontato, e all’orizzonte fiammeggiava un ampio bagliore rosso, che preannunciava tempo ventoso per il giorno dopo. C’era silenzio. Scrutando nella direzione dove l’anno prima gli era comparso per la prima volta il monaco nero, Kovrin rimase una ventina di minuti, finché il crepuscolo non cominciò a offuscarsi…
Quando, languido, insoddisfatto, tornò a casa, il vespro era già finito. Egor Semënyč e Tanja erano seduti sui gradini della terrazza e bevevano il tè. Stavano parlando di qualcosa ma, vedendo Kovrin, tacquero all’improvviso, e lui concluse dalla loro faccia che stavano parlando di lui.
«Mi sembra che sia il momento di bere il tuo latte» disse Tanja al marito.
«No, non è il momento…» rispose lui sedendosi sul gradino più basso.
«Bevilo tu. Io non ne ho voglia.»
Tanja scambiò un’occhiata ansiosa col padre e disse con voce colpevole:
«Lo vedi anche tu che il latte ti fa bene.»
«Sì, molto bene!» ridacchiò Kovrin. «Mi congratulo con voi: da venerdì ho preso un’altra libbra.»
Si strinse forte la testa tra le mani e disse con angoscia: «Perché, perché mi avete curato? Preparati al bromuro, ozio, bagni caldi, sorveglianza, pusillanime paura a ogni sorso, a ogni passo: ne uscirò idiota, alla fin fine. Uscivo di senno, avevo la mania di grandezza, però almeno ero allegro, energico e persino felice, ero interessante e originale.
Ora sono diventato più giudizioso e posato, però sono uguale a tutti gli altri: sono una mediocrità, a vivere mi annoio… Oh, come siete stati crudeli con me! Avevo allucinazioni, ma a chi dava fastidio? Domando: a chi dava fastidio?»
«Lo sa Dio cosa stai dicendo!» sospirò Egor Semënyč. «Vien persino noia ad ascoltarti.»
«E non ascoltatemi.»
La presenza della gente, in particolare di Egor Semënyč, ormai irritava Kovrin, gli dava risposte secche, fredde e perfino sgarbate, e lo guardava solo con derisione e con odio, ed Egor Semënyč rimaneva imbarazzato e tossicchiava colpevole, anche se non si sentiva minimamente in colpa.
Senza capire perché le loro relazioni cordiali, bonarie fossero cambiate così bruscamente, Tanja si strinse al padre e lo guardò negli occhi con ansia; voleva capire e non poteva, e le era chiaro soltanto che le relazioni ogni giorno diventavano sempre peggiori, che il padre negli ultimi tempi era molto invecchiato, mentre il marito era diventato irritabile, capriccioso, ipercritico e poco interessante.
Lei non riusciva più a ridere e a cantare, a pranzo non mangiava nulla, non dormiva per tutta la notte, in attesa di qualcosa di tremendo, e si estenuava tanto che una volta giacque sfinita dal pranzo fino a sera.
Durante le preghiere serali le sembrava che il padre piangesse, e ora che erano tutti e tre in terrazza faceva sforzi su di sé per non pensarci.
«Che fortunati Buddha e Maometto o Shakespeare, che i cari parenti e i dottori non li hanno curati dall’estasi e dall’ispirazione!» disse Kovrin. «Se Maometto per i nervi avesse preso bromuro di potassio, lavorato solo due ore al giorno e bevuto latte, di quest’uomo notevole sarebbe rimasto poco quanto del suo cane.
Se dottori e parenti cari continuano così, l’umanità diventerà ottusa, la mediocrità verrà considerata genio e la civiltà andrà in rovina. Se voi sapeste» disse Kovrin con stizza, «quanto vi sono grato!»
Provava una forte irritazione e, per non dire nulla di troppo, si alzò in fretta e andò in casa.
C’era silenzio e dalle finestre aperte entrava dal giardino un aroma di tabacco e di gialappa. Nella enorme sala buia sul pavimento e sul pianoforte erano le macchie verdi della luce della luna. A Kovrin vennero in mente gli entusiasmi dell’estate passata, quando c’era lo stesso odore di gialappa e alle finestre brillava la luna. Per far tornare l’umore dell’anno prima andò in fretta nel suo studio, si accese un sigaro forte e ordinò al cameriere di portargli del vino. Ma il sigaro in bocca era amaro e disgustoso e il vino non aveva lo stesso gusto dell’anno prima.
Cosa vuol dire perdere l’abitudine! Per il sigaro e i due sorsi di vino cominciò a girargli la testa e gli vennero le palpitazioni, così che fu costretto a prendere il bromuro di potassio.
Prima di andare a letto, Tanja gli disse:
«Mio padre ti adora. Tu sei arrabbiato con lui per qualcosa, e questo lo sta uccidendo. Guarda: non invecchia di giorno in giorno, ma di ora in ora. Ti prego, Andrjuša, in nome di Dio, in nome del tuo povero padre, in nome della mia tranquillità, sii tenero con lui!»
«Non posso e non voglio.»
«Ma perché?» domandò Tànja cominciando a tremare con tutto il corpo.
«Spiegamelo, perché?»
«Perché non è in simpatia con me, ecco tutto» disse Kovrin sgarbato e si strinse nelle spalle. «Ma non parliamo di lui: è tuo padre.»
«Non riesco, non riesco a capire!» disse Tanja premendosi le tempie con lo sguardo fisso. «Qualcosa di incomprensibile, di tremendo sta succedendo a casa nostra. Sei cambiato, non sembri più tu… Tu, persona intelligente, straordinaria, te la prendi per sciocchezze, ti immischi in litigi… Ti agiti per minuzie tali, che certe volte viene da meravigliarsi e da non crederci: ma sei tu? Su, su, non arrabbiarti, non arrabbiarti» continuò, spaventata dalle sue stesse parole e baciandogli le mani.
«Sei intelligente, buono, nobile. Sarai giusto con mio padre. È così buono!»
«Non è buono, è bonario. Gli ometti da vaudeville tipo tuo padre, con la faccia sazia e bonaria, straordinariamente ospitali e bislacchi, una volta mi commuovevano e mi facevano ridere sia nei romanzi, sia nei vaudeville, sia nella vita, mentre ora mi disgustano. Sono egoisti fino al midollo. Più di tutto mi disgusta la loro pancia piena e questo ottimismo gastrico, proprio al toro e al porco.»
Tanja si sedette sul letto e posò la testa sul cuscino.
«È una tortura» disse, e dalla voce era evidente che era sfinita e che le pesava parlare. «Da quest’inverno neanche un momento di serenità… È tremendo, Dio mio! Io soffro…»
«Sì, certo, io sono Erode, e tu e il tuo paparino siete i bambini di Betlemme. Certo!»
La sua faccia parve a Tanja brutta e sgradevole. L’odio e l’espressione derisoria non gli stavano bene. Già prima aveva notato che nella sua faccia mancava qualcosa come se, da quando si era tagliato i capelli, fosse cambiata anche la faccia. Le venne voglia di dirgli parole offensive, ma subito dopo aver sorpreso in sé il sentimento ostile, si spaventò e uscì dalla camera da letto.
IX
Kovrin fu nominato titolare di una cattedra. La lezione introduttiva fu fissata per il due dicembre, come indicato dall’avviso affisso nel corridoio dell’università. Ma il giorno stabilito egli informò con un telegramma il direttore didattico che non avrebbe tenuto la lezione per malattia.
Perdeva sangue dalla gola. Sputava sangue, ma un paio di volte al mese ne perdeva copiosamente, e allora restava moltissimo indebolito e cadeva in uno stato di sonnolenza. Questa malattia non lo spaventava in modo particolare, poiché sapeva che la sua povera mamma aveva vissuto esattamente con la stessa malattia dieci anni, anche di più; anche i dottori gli assicuravano che non era pericoloso, e gli consigliavano solo di non agitarsi, di condurre una vita regolata e di parlare meno.
In gennaio la lezione non si tenne per lo stesso motivo, e in febbraio era ormai tardi per iniziare un corso. Lo si dovette rimandare all’anno successivo.
Non viveva più con Tanja, ma con un’altra donna che aveva due anni più di lui e lo accudiva come un bambino. Era di umore pacifico, remissivo: si sottometteva volentieri, e quando Varvara Nikolaevna – così si chiamava la sua amica – si preparò a portarlo in Crimea, lui accettò, anche se aveva il presentimento che da questo viaggio non sarebbe venuto nulla di buono.
Arrivarono a Sebastopoli di sera e si fermarono in un albergo per riposarsi e l’indomani andare a Jalta. Tutti e due erano stanchi del viaggio. Varvara Nikolaevna bevve il tè, andò a letto e presto si addormentò. Ma Kovrin non andò a letto. Ancora a casa, un’ora prima di andare alla stazione, aveva ricevuto una lettera da Tanja e non si era deciso a dissuggellarla, e ora l’aveva in una tasca laterale, e pensarci gli dava una sgradevole agitazione.
Sinceramente, nel profondo dell’anima, il suo matrimonio con Tanja ora lo considerava un errore, era contento di essersi definitivamente separato da lei, e il ricordo di questa donna, che alla fine si era trasformata in una reliquia ambulante in cui sembrava tutto morto tranne i grandi occhi intelligenti che guardavano fissi, il ricordo di lei suscitava in lui solo pena e rabbia verso se stesso.
La calligrafia sulla busta gli fece venire in mente che un paio d’anni prima era stato ingiusto e crudele, che aveva sfogato su persone prive di qualsiasi colpa il suo vuoto spirituale, la noia, la solitudine e l’insoddisfazione per la vita.
A proposito gli venne in mente che una volta aveva stracciato a pezzettini la tesi e tutti gli articoli scritti nel periodo della malattia, e li aveva buttati dalla finestra, e i pezzettini, volando col vento, si erano appiccicati ad alberi e fiori; a ogni riga vedeva una presunzione strana, del tutto infondata, uno zelo frivolo, impertinenza, mania di grandezza, e gli dava l’impressione di leggere la descrizione dei propri difetti; ma quando l’ultimo quaderno era stato strappato ed era andato fuori dalla finestra, chissà perché gli era venuto un accesso improvviso di stizza e di amarezza, era andato dalla moglie e le aveva detto molte parole spiacevoli.
Dio mio, quanto l’aveva tormentata! Una volta, desiderando farle del male, le aveva detto che suo padre nella loro storia aveva avuto un ruolo sgradevole, dato che gli aveva chiesto di sposarla; Egor Semënyč l’aveva sentito per caso, era corso nella stanza e dalla disperazione non era riuscito a dire neanche una parola, spostava solo il peso da una gamba all’altra e mugolava qualcosa di strano, come se gli si fosse paralizzata la lingua, mentre Tanja, guardando il padre, aveva lanciato un urlo straziante ed era svenuta. Era stato mostruoso.
Tutto questo gli veniva in mente guardando la nota calligrafia. Kovrin uscì sul balcone; non c’era vento, non faceva freddo e c’era odore di mare. La splendida baia rifletteva la luna e le luci e aveva un colore difficile da descrivere. Era una mescolanza tenue e calda di blu e verde; a tratti l’acqua per colore assomigliava al vetriolo blu, a tratti, sembrava, la luce della luna si era condensata e riempiva la baia al posto dell’acqua, e nel complesso che armonia di colori, che sensazione di pace, tranquillità, elevatezza!
Al piano di sotto, sotto la terrazza, le finestre, probabilmente, erano aperte, perché si sentivano distinte le voci femminili e le risate. Evidentemente c’era una festa.
Kovrin fece uno sforzo su se stesso, dissuggellò la lettera e, entrando in camera, lesse:
“Ora è morto mio padre. Te ne sono obbligata, dato che sei stato tu a ucciderlo. Il nostro frutteto sta andando in rovina, degli estranei ci si sentono già padroni, ossia succede proprio quello che temeva tanto il mio povero padre. Anche di questo ti sono obbligata. Ti odio con tutta la mia anima e desidero che tu muoia al più presto. Oh, quanto soffro! Un dolore insopportabile mi brucia dentro… Che tu sia maledetto. Ti avevo preso per un uomo straordinario, per un genio, ti ho amato, ma è venuto fuori che eri pazzo…”
Kovrin non riuscì a continuare a leggere, stracciò la lettera e la buttò. Fu invaso da un’inquietudine simile a paura. Dietro il paravento dormiva Varvara Nikolaevna, e la si sentiva respirare; dal piano di sotto arrivavano voci femminili e risate, ma aveva la sensazione che in tutto l’albergo oltre a lui non ci fosse anima viva. Per il fatto che l’infelice Tanja distrutta dal dolore nella lettera l’aveva maledetto e gli aveva augurato la morte si senti- va atterrito, e lanciava occhiate fugaci alla porta come temendo che entrasse in camera e riprendesse il controllo di lui quella forza sconosciuta che in poco meno di due anni aveva prodotto tante distruzioni nella sua vita e nella vita dei suoi cari.
Sapeva già per esperienza che quando imperversano i nervi, l’antidoto migliore è il lavoro. Bisogna sedersi alla scrivania e costringersi a ogni costo a concentrarsi su un pensiero qualsiasi. Prese dalla sua cartella rossa un quadernino con l’abbozzo di uno schema di una breve opera compilativa preparata prevedendo di sentire la mancanza del lavoro in Crimea.
Si sedette alla scrivania e si occupò di questo schema, e gli sembrava che gli tornasse l’umore pacifico, remissivo, indifferente. Il quadernino con lo schema lo fece perfino riflettere sulla vanità del mondo. Pensava a quanto pretende la vita, in cambio di quei beni insignificanti o del tutto normali che può dare all’uomo. Per esempio, per avere una cattedra a quarant’anni, essere un normale professore, esporre in un linguaggio consunto, noioso, pesante pensieri comuni e comunque non suoi, insomma per raggiungere la posizione di studioso mediocre lui, Kovrin, aveva dovuto studiare quindici anni, lavorare giorno e notte, subire una pesante malattia psichica, sopportare un matrimonio fallito e fare molte sciocchezze e ingiustizie di ogni tipo che sarebbe stato piacevole non ricordare.
Kovrin ora si rendeva conto benissimo di essere la mediocrità, e ci si rassegnava volentieri dato che, secondo lui, ognuno deve essere contento di quello che è.
Lo schema lo stava tranquillizzando, ma la lettera strappata bianca sul pavimento gli impediva di concentrarsi. Si alzò dalla scrivania, raccolse i pezzettini della lettera e li buttò dalla finestra, ma dal mare soffiava un vento leggero, e i pezzettini si sparsero sul davanzale. Fu ripreso da inquietudine simile a paura, e cominciò a sembrargli che in tutto l’albergo oltre a lui non ci fosse anima viva… Uscì sul terrazzo. La baia, come viva, lo guardava con una moltitudine di occhi celesti, blu, turchesi e di fuoco e lo attirava a sé. In effetti era caldo e afoso e un bagno non avrebbe guastato.
All’improvviso al piano inferiore sotto il terrazzo cominciò a suonare un violino, e due dolci voci femminili si misero a cantare. Nella romanza che cantavano da basso si parlava di una fanciulla dalla fantasia malata che sentiva di notte in giardino dei suoni misteriosi e decideva che era una sacra armonia, incomprensibile a noi mortali… A Kovrin mancò il fiato e gli si strinse il cuore dalla malinconia, e la gioia miracolosa, dolce che aveva ormai dimenticato da un pezzo prese a fremergli nel petto.
Un’altra colonna nera simile a un vortice o a una tromba d’acqua apparve sull’altra riva della baia. Attraversava la baia a velocità spaventosa in direzione dell’albergo, diventando sempre più piccola e scura, e Kovrin fece appena in tempo a scansarsi per lasciarla passare… Un monaco con la testa canuta scoperta e le sopracciglia nere, a piedi nudi, le braccia incrociate sul petto, gli sfrecciò accanto e si fermò in mezzo alla stanza.
«Perché non mi hai creduto?» domandò con aria di rimprovero, guardando tenero Kovrin. «Se allora avessi creduto che sei un genio, questi due anni non li avresti passati in modo così triste e misero.»
Kovrin credeva già di essere un eletto da Dio e un genio, gli vennero in mente nitide tutte le conversazioni precedenti col monaco nero e voleva parlare, ma il sangue gli uscì dalla gola dritto sul petto e lui, non sapendo che fare, si passava le mani sul petto e i polsini gli si intrisero di sangue. Voleva chiamare Varvara Nikolaevna che dormiva dietro il paravento, fece uno sforzo e disse:
«Tanja!»
Cadde a terra e, sollevandosi sulle braccia, chiamò di nuovo:
«Tanja!»
Chiamava Tanja, chiamava il grande giardino con i fiori lussureggianti spruzzati di rugiada, chiamava il parco, i pini con le radici pelose, il campo di segale, la sua scienza miracolosa, la sua gioventù, il coraggio, la gioia, chiamava la vita, che era così bella.
Vide sul pavimento vicino alla sua faccia una grande pozza di sangue e dalla debolezza non riusciva più a dire nemmeno una parola, ma una felicità inesprimibile, senza limiti riempì tutto il suo essere. Da basso, sotto il terrazzo, suonavano una serenata, e il monaco nero gli sussurrò che lui è un genio e che muore solo perché il suo debole corpo umano ha perso l’equilibrio e non può più fare da involucro a un genio.
Quando Varvara Nikolaevna si svegliò e venne fuori dal paravento, Kovrin era già morto, e sulla sua faccia era rimasto impresso un sorriso beato.
…
..
.
Anton Čechov – Il monaco nero
Ru: Čërnyj monah (1894)
Racconto russo – letteratura russa
Testo completo tradotto in italiano
Anton Čechov The black monk versione in inglese > qui
Anton Čechov Tutti i racconti > qui
Anton Čechov Lista di tutte le opere > qui